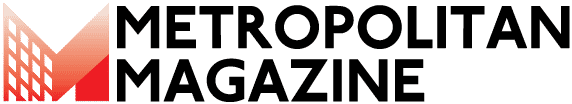“Il Buco”, secondo film italiano in concorso a Venezia, appartiene a un genere ossimoro, inclassificabile come tutti i lavori di Michelangelo Frammartino, capaci di emozionare senza bisogno di attori professionisti, di dialoghi e di musica. Il suo è un cinema che decentralizza la figura umana, negandole la supremazia su animali, piante, e quanto vive in terra come in cielo.
“Il Buco” ci trasporta, letteralmente, nell’Italia di sessant’anni fa. Il paese con la tivù in bianco e nero del bar piazzata per strada e la gente seduta davanti, i panni lavati al torrente, il medico condotto che visita sul pianerottolo. Ma anche le tenebre affascinanti esplorate da questi ragazzi che andavano ‘in direzione contraria’, dal Nord verso Sud, in un Paese che emigrava verso le fabbriche e il lavoro.
l punto di vista adottato dal regista è quello di un vecchio pastore, che guarda il mondo, cioè le sue bestie e gli speleologi all’opera, dall’alto. E’ come “il punto di vista di Dio” di cui parlava Fabrizio De André. La discesa nella grotta – coi mezzi rudimentali di allora – ha una forza visiva che evoca le illustrazioni di Gustave Doré per la ‘Commedia’ dantesca. Ma come sempre a commuovermi ancora di più c’è questo senso di pari dignità del vivente che Frammartino comunica, le voci umane alla pari col vento, le foglie, i versi degli animali, come se il francescano Cantico delle Creature trovasse forma di cinema.
Trama “Il Buco”
Durante il boom economico degli anni Sessanta, l’edificio più alto d’Europa viene costruito nel prospero Nord Italia. All’altra estremità del paese, un gruppo di giovani speleologi esplora la grotta più profonda d’Europa nell’incontaminato entroterra calabrese. Si raggiunge, per la prima volta, il fondo dell’abisso del Bifurto, a 700 metri di profondità. L’avventura degli intrusi passa inosservata agli abitanti di un piccolo paese vicino, ma non al vecchio pastore dell’altopiano del Pollino la cui vita solitaria comincia ad intrecciarsi con il viaggio del gruppo. Il buco racconta di una bellezza naturale che lascia senza parole e sfiora il mistico; una esplorazione attraverso le profondità sconosciute della vita e della natura che mette in parallelo due grandi viaggi interiori.
Nel gennaio 2007, il sindaco del paese calabrese dove stavo girando Le quattro volte, mi ha portato a fare un giro del Pollino. “Devi vedere le meraviglie di queste montagne!”, ha detto. Mi ha condotto in una dolina dove si poteva vedere un magro taglio nel terreno. Ero perplesso, deluso. Il sindaco, invece, entusiasta e fiero, ha gettato in quel vuoto un grosso sasso. È stato inghiottito dall’oscurità. Il fondo era così profondo che non si vedeva né si sentiva nulla. Quella scomparsa, quella mancanza di risposta, mi ha dato un’emozione fortissima. Quello strano posto mi è rimasto impresso, richiamandomi a sé anni dopo, per interrogarlo e creare un progetto nel buio silenzioso dell’Abisso del Bifurto.