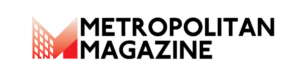Chi di noi non ha mai sognato, leggendo o ascoltando le avventure della curiosa Sirenetta, della materna Biancaneve o di Cenerentola, sognatrice per eccellenza? Chi non ha mai desiderato di vivere in un mondo fatato, popolato da topolini che si rivelano abili sarti o fate madrine che trasformano le zucche in carrozze scintillanti? Le fiabe fanno parte della cultura popolare e dei ricordi di generazioni di bambini, cresciuti a pane e Cappuccetto Rosso.
Complice l’intervento della Disney, che ha trasformato molti di questi racconti in capolavori d’animazione, siamo abituati a ripensare alle vicende di principi valorosi e principesse coraggiose con un sorriso, rassicurati dal lieto fine d’ordinanza. La realtà, tuttavia, è decisamente diversa. Quelle che a noi sono arrivate come novelle cariche di elementi fantastici e buoni sentimenti, erano in origine molto più tetre.
Perrault, i Fratelli Grimm, Walt Disney: i “Signori delle Fiabe”
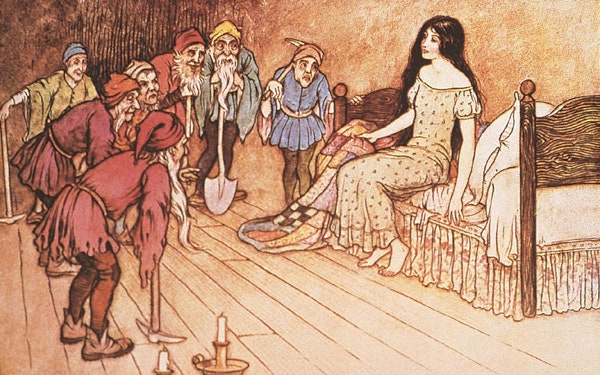
Le fiabe, come si può immaginare, nacquero in forma orale. Si trattava, infatti, di storielle di un passato lontano, inventate per intrattenere gli adulti, piuttosto che i più piccini. Solo molto tempo dopo, ciò che per secoli era stato tramandato di bocca in bocca, venne trascritto. Fu Charles Perrault, scrittore alla corte di Re Luigi XIV, a riunire una parte del materiale in una raccolta, intitolata I racconti di Mamma Oca, pubblicato nel 1687. Non lasciatevi però ingannare dal nome rassicurante, il contenuto del volume era assolutamente macabro. Lo scopo di questo genere di narrazione, dopotutto, era impartire delle lezioni morali, e all’epoca non si andava troppo per il sottile.
Furono i due linguisti e filologi tedeschi Jacob Ludwig Karl e Wilhelm Karl Grimm, i leggendari Fratelli Grimm, a dare inizio a un vero e proprio processo di edulcorazione. Non da subito, però. Le prime edizioni de Le fiabe del focolare, antologia da loro redatta nel 1812, erano molto più fedeli alla tradizione popolare e, dunque, ancora abbondantemente cruente. Le riedizioni successive, però, vennero riadattate per orecchie e occhi più innocenti, e i dettagli più sanguinolenti furono eliminati. A spazzare via gli ultimi residui di orrore ci pensò Walt Disney, che smussò ulteriormente le pagine degli autori. D’altronde, si sa, «Con un poco di zucchero la pillola va giù».
Le versioni originali, tuttavia, restano una lettura interessante, che vale la pena conoscere. Ecco, di seguito, una selezione delle fiabe nella loro foggia più antica e inquietante. Chissà, magari qualche lettore più cinico le preferirà al classico lieto fine. Agli altri, invece, non resta che rovinarsi per sempre l’infanzia.
Biancaneve, la più bella e vendicativa del reame
Tutti abbiamo in mente la dolce principessina perseguitata dalla crudele matrigna, che trova rifugio nella casetta dei sette nani. Nella redazione del 1812 dei Grimm, tuttavia, Biancaneve non è una fanciulla, ma una bambina. Sua madre, puntasi il dito, sogna di avere una figlia bianca come la neve, nera come l’ebano, rossa come il sangue. Cosa che, in effetti, avviene. Invidiosa della sua bellezza, quando la piccola compie sette anni, la donna ordina a un cacciatore di ucciderla e di portarle il suo fegato e i polmoni, per cucinarli con sale e pepe.
Sfuggita al suo assassino, la bimbetta giunge dai nani, ma la crudele megera la trova e tenta ripetutamente di farla fuori, dapprima con un pettine avvelenato, poi con la famosa mela. Dopo essere tornata in vita non grazie al principe, ma a dei servitori, che scuotono il suo corpo, facendole sputare il boccone fatale, Biancanove medita vendetta. Il giorno delle sue nozze, riceve la genitrice con un regalo speciale. «Erano state preparate per la madre delle scarpe di ferro incandescenti.»-si legge-«Fu costretta a indossarle e danzare e danzare, fino ad avere i piedi orribilmente bruciati, e senza poter smettere fino a quando, ballando ballando, fu lei a cadere a terra morta.». Chi la fa, l’aspetti. Nel 1819, la madre diventa matrigna e, nei seguenti rimaneggiamenti, spariscono anche le scarpe arroventate e l’accenno al cannibalismo.
Cenerentola, quando si dice “Darsi la zappa sui piedi”
Tra le fiabe più antiche della storia, sembra che Cenerella e i suoi piedi di fata vengano addirittura dall’Egitto. Riscritta da Perrault, ma anche da Giambattista Basile, che la inserisce ne Lo cunto de li cunti, la parabola della povera orfanella che trova il suo principe azzurro grazie alla scarpetta di cristallo nasconde dei risvolti parecchio feroci. Secondo i Grimm, per riuscire ad entrare nella calzatura, infatti, le sorellastre invidiose, consigliate dalla loro madre, si mozzano i piedi; la maggiore taglia via un dito, la minore il calcagno. Il giovane rampollo, però, viene avvisato da due colombelle dell’inganno subito. «Sposta lo sguardo, sposta lo sguardo: c’è sangue nella scarpetta, la scarpetta è troppo piccola, la vera sposa sta ancora in casa». Questi volatili dovevano avercela proprio con le due arpie; il giorno del matrimonio di Cenerentola, si avventano sulle malcapitate, cavando loro gli occhi per punizione. Come se una mutilazione non fosse sufficiente.
Cappuccetto Rosso, cronacaca nera
La metafora del Lupo che adesca la ragazzina perduta nel bosco lascia ben poco all’immaginazione; si tratta di un chiaro rimando alla pedofilia. Quello che, però, a noi è arrivato come un sospetto fondato, ne Le Petit Chaperon Rouge di Perrault, diventa un caso di cronaca nera. Prima di tutto, il villain ammazza la nonna e dà in pasto le sue carni all’ignara nipotina. Inoltre, la figura salvifica del cacciatore è assente, ma ad essere presenti sono dei riferimenti sessuali espliciti. L’animale, infatti, costringe Cappuccetto a togliersi i vestiti e a giacere nel letto con lui.
La più atroce delle fiabe si conclude con la seguente spiegazione: «Da questa storia si impara che i bambini, e specialmente le giovanette carine, cortesi e di buona famiglia, fanno molto male a dare ascolto agli sconosciuti; e non è cosa strana se poi il Lupo ottiene la sua cena. Dico Lupo, perché non tutti i lupi sono della stessa sorta; ce n’è un tipo dall’apparenza encomiabile, che non è rumoroso, né odioso, né arrabbiato, ma mite, servizievole e gentile, che segue le giovani ragazze per strada e fino a casa loro. Guai! a chi non sa che questi lupi gentili sono, fra tali creature, le più pericolose!». Già allora si puntava il dito contro la vittima, anziché prendersela con il carnefice.
La bella addormentata nel bosco, un caso di necrofilia
L’horror, stavolta, è tutto made in Italy. Nel racconto antesignano della più romantica La Belle au bois dormant, denominato Sole, Luna e Talia, la protagonista, che non si chiama Aurora, né Rosaspina ma, appunto, Talia, cade addormentata a causa di una lisca di lino incastrata sotto l’unghia. A trovarla è un re che, invaghitosi del suo aspetto, dopo aver provato a risvegliarla, la violenta ripetutamente, lasciandola incinta e tornando nel suo regno. Ancora in stato comatoso, la giovinetta partorisce due gemelli, Sole e Luna, che riescono a ridestarla. I tre devono vedersela con la regina, moglie dello stupratore e folle di gelosia, che cerca di eliminarli e di cucinare i bambini, finendo però per morire nel rogo predisposto per la sua “rivale”.
Hänsel e Gretel, parenti serpenti
Si dice che il racconto sia in qualche modo ispirato a fatti realmente avvenuti. Nulla di certo, se non che, anche nella vicenda dei due fratellini, non sia possibile consegnare a nessuno il premio di “Mamma dell’anno”. Per i più è una matrigna senza scrupoli a convincere il taglialegna a disfarsi della sua prole. Nella prima edizione, invece, è la madre biologica di Hänsel e Gretel a spedire i due poveretti nel bosco, nella speranza di avere due bocche in meno da sfamare. In entrambi i casi, comunque, il padre dei pargoletti non oppone particolare resistenza. Ah, queste famiglie tradizionali.
La sirenetta, “cornuta e mazziata”
Quando si parla di “unhappy ending”, è impossibile non citare Hans Christian Andersen. Il poeta danese è rinomato per i suoi finali tutt’altro che felici; ne sanno qualcosa La piccola fiammiferaia, o La regina delle nevi. Il suo capolavoro, tuttavia, nonché la sua fiaba più iconica, è La Sirenetta, che ha ispirato la costruzione di una statua a lei dedicata e il bellissimo Classico Disney del 1989. Se, però, state pensando alla chioma fulva di Ariel, al bacchettone Sebastian e allo stonato gabbiano Scuttle, resterete delusi.
La quindicenne dalla coda di pesce non coronerà mai il suo sogno d’amore. Non potendo parlare, dopo aver ceduto la sua voce alla Strega del Mare in cambio di un paio di gambe, non riesce a conquistare il principe. Le sorelle corrono in suo aiuto, consegnandole un pugnale magico che potrebbe spezzare il maleficio. Basterebbe accoltellare il ragazzo e bagnare i piedi nel suo sangue, per tornare al sicuro in fondo al mar. La poverina, però, troppo innamorata per commettere un tale omicidio, si sacrifica. Quando il giovane sposa un’altra principessa, la sirena si dissolve in spuma, ed è in procinto di morire. La sua bontà, però, viene premiata, e diventa una figlia dell’aria, che potrà ottenere un’anima e trovare la pace in Paradiso dopo trecento anni di buone azioni. Per ogni bambino buono a cui sorriderà, le verrà risparmiato un anno di attesa; per ogni birbante, invece, piangerà e sconterà un giorno di prova per ogni lacrima. Forse, tutto sommato, la spuma di mare non sarebbe stata una fine così terribile.
…E vissero tutti (in)felici e (s)contenti.
Federica Checchia
Seguici su Google News