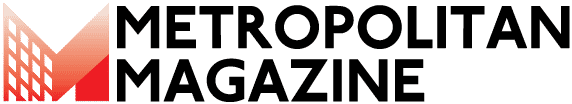Quando si parla di femminismo si parla anche e soprattutto di pinkwashing. Il lato oscuro di questo movimento sociale, politico e ideologico è il finto atteggiamento di apertura verso tale pensiero che cela, invece, un uso prettamente strumentale della tematica.
Pinkwashing, storia di un termine che abusa di un’ideologia

Il termine pinkwashing è il risultato di una crasi fra “pink” – rosa, il colore associato al femminismo e fin dagli anni ’70 all’attivismo LGBT – e “whitewashing“; letteralmente, imbiancare o nascondere. L’etimologia e la semantica della parola, quindi, rimanda alla ”denuncia sociale” che la stessa parola veicola: il pinkwashing non è altro che un atteggiamento di finzione che fa credere di sostenere un atteggiamento di apertura nei confronti dell’emancipazione femminile ma che, tuttavia, ne sfrutta l’ideologia per scopi di marketing, strumentalizzandola per fini prettamente aziendali. Rivendicazione di genere, femminismo, lotte per i diritti, diventano funzionali per una qualsiasi azienda che vuole accalappiare quella fetta di pubblico sensibile a tali argomenti e giungere a una posizione alta di mercato.
Insomma, l’attivismo vende: per cui, la vicinanza a tali temi è solo una scelta superficiale, estetica, e che non dà alcun beneficio alla causa etica. Stessa politica applicata verso la comunità LGBTQ+: anche per il rainbow washing gli scopi sono esclusivamente atti a implementare il marketing politico e aziendale dei vari brand. Non a caso, queste operazioni di marketing aziendale si sono estese anche ad altri temi che infervorano molto l’opinione pubblica; un esempio calzante è quello dell’ambientalismo dove, nel tempo, si sono verificati numerosi esempi si greenwashing, ecologismo di facciata, da cui deriva il neologismo pinkwashing.
Genesi del concetto come critica che fa leva su sentimenti di inclusività
Mostrarsi progressisti, impegnati nel sostegno di tematiche inclusive, e attivisti in tali ambiti risulta proficuo in termini di vendita. Riprendendo un’antica espressione greca καλὸς καὶ ἀγαθός, – kalòs kai agathòs – , letteralmente resa con ”bello e anche buono”, risulta naturale procedere con un parallelismo. La kalokagathia greca era un concetto nato ad Atene nella seconda metà del V secolo a.C. per opera dei sofisti, e sottintendeva il possedimento generale di ogni virtù. Ciò che è bello, secondo questa concezione, non può non essere buono e ciò che è buono è necessariamente bello, inteso come moralmente consono e virtuoso.
Applicando questa locuzione al pinkwashing moderno si noti l’analogia distribuita in ambito di vendita: gadget rosa, prodotti per la cura, igiene, indumenti a sostengo dell’ inclusività faranno la crescita del brand poiché percepito, dal pubblico sensibile alle tematiche, come esteticamente godibile, certo, ma soprattutto come etico, progressista, virtuoso e per nulla utilitaristico o mercificato ai fini economici.
Il neologismo pinkwashing nasce proprio come critica a una circostanza apparentemente morale sulla scia del greenwashing; espressione coniata dall’ambientalista Jay Westerveld nel 1986. Nei primi anni 2000 il termine è stato rimodellato e riadattato per riferirsi alla lotta contro il cancro al seno. La Breast Cancer Association attraverso la figura di Barbara Brenner, suo membro storico, conia il termine pinkwashing per portare alla luce quelle finte campagne pubblicitarie che, grazie alla logica del profitto, creavano azioni di marketing servendosi e approfittandosi di tematiche nobili. Il consumatore, vedendo la limpidezza del brand in termini di sensibilità e moralità, era influenzato indirettamente a preferire i loro prodotti. Dal canto dell’azienda, militare su una tematica virtuosa significava ottenere maggiori introiti e consensi, distogliendo il compratore-consumatore dal porre l’attenzione sulla eventuale scarsa qualità del materiale o degli ingredienti usati.
Pink ribbon culture, il marketing del cancro al seno
Nel 1991 Charlotte Haley, colpita da cancro al seno, inizia a cucire dei fiocchi color pesca a cui allega una cartolina di denuncia per i pochi fondi stanziati dal governo per questa circostanza. Un noto brand di cosmetica si accorge della potenzialità dell’idea, così propone alla Haley di acquistare i suoi fiocchi; ma quando Charlotte, immaginando l’intento, si rifiuta il noto brand cambia il colore dei fiocchi tingendoli di rosa. Tutt’oggi, infatti, il fiocco rosa è simbolo della lotta contro il cancro al seno.
Il brand si appropria quindi di un’idea altrui, la sfrutta e guadagna in una logica tutt’altro che trasparente. Nasce, quindi, una delle campagne più longeve degli ultimi anni: legarsi a una causa sociale, allegare a essa un simbolo riconoscibile, combatterla. Ottime premesse, se non fosse che per vendere un prodotto e associarsi virtuosamente alla causa che si sostiene, si deve avere chiaro il pubblico a cui si vuole presentare quel prodotto; non resta quindi che rivolgersi a chi ha un effettivo potere d’acquisto. In quest’ottica erano le donne bianche, appartenenti a una classe borghese e di mezza età; il target della clientela tipo di aziende cosmetiche di lusso.
Insomma, una discriminazione nella già poca trasparenza di intenti. Chi poteva accedere al sistema sanitario americano e poteva permettersi di acquistare make-up di lusso era il prototipo a cui si rivolgeva l’operazione marketing pennellata di rosa.
Pinkwashing oggi: la poca trasparenza dell’era social
Il pinkwashing oggi si muove, per lo più, nell’ambito della produzione fast poiché la questione femminista resta sempre una tematica allettante. L’emancipazione femminile ammalia un gran fetta di pubblico; il consumatore vede nell’identità del brand una purezza nobiliare d’intenti che lo porta a fidarsi dell’azienda per poi acquistare. Un circolo che si ripete ”a favore della causa” a cui non resta proprio nulla in termini materiali.
Questo femminismo di facciata pullula anche fra gli influencer e nel mondo digitale con pagine dedicate al tema. In questo caso, sfruttare temi cari all’opinione pubblica porta a far salire l’engagement a livello social. Se si piazza una questione sociale sensibile, e poi un prodotto, è più facile che l’utente apprezzi ciò che gli si presenta; sarà portato a condividere, commentare, insomma creare traffico su un dato profilo/post proprio perché la reazione dell’utente è dettata dal coinvolgimento emotivo che quella pubblicazione è riuscita a creare.
Una vera e propria strategia messa in pratica sia da alcune influencer che da alcuni spazi social nati come femministi; quest’ultimi, rimandano a immagini di donne di potere, sfruttando un certo tipo di retorica che esalta modelli di riferimento femminili popolari. A ciò si aggiunge il continuo enfatizzare del modello di auto-affermazione femminile che serve, a conti fatti, per sponsorizzare prodotti da vendere per l’universo femminile stesso. Lo scopo del femminismo è sempre politico e mai commerciale. A questo punto ci si ritrova in una mercificazione della lotta in termini di profitto, che con l’ideologia di base del femminismo non c’entra proprio nulla. È importante approcciarsi ai contesti, online e offline, tenendo sempre a mente che l’attivismo, in ogni ambito, è un’attività il cui fine è produrre cambiamenti politici e sociali, non aumentare la produzione di guadagni e introiti.
Stella Grillo
Seguici su Google News