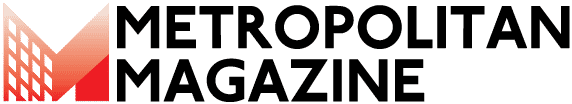Alessio Bondì, cantante e musicista trentenne, siciliano d’origine e romano d’adozione (ma grande viaggiatore e quindi cittadino del mondo) ci racconta in quest’intervista “Nivuru”, il suo secondo album di studio, in uscita domani.
Un lavoro straordinario, sorprendente, di cui proveremo a darvi conto nei suoi tanti colori e provenienze nel corso di una recensione, pubblicata anch’essa domani. Per oggi, nel frattempo, affidiamoci alle parole di Alessio, la miglior introduzione possibile…
Partiamo dal titolo del disco (“Nero”): mi affascina l’ambivalenza legata ai significati cromatici ed emotivi che questo colore può assumere. E trovo molto interessante la presenza di un bisogno (apparentemente) più celato eppure espresso tra i solchi dell’album: oltre agli umori, ai toni, ai colori in gran parte festivi/luminosi/vivaci, si cela infatti un forte bisogno di solitudine, di spiritualità,
di riequilibrio. Utile per esorcizzare o rigenerarsi e quindi lasciarsi alle spalle – complice l’atto creativo – quel ‘Nivuru’.
Ti senti ancora in sintonia con quel ‘mood’ oppure trovi faccia parte del passato?
- “Si scrive per individuare i nodi, si canta per scioglierli. L’ho scritto, l’ho arrangiato, l’ho registrato, missato, masterizzato ma non l’ho ancora cantato in faccia alle persone questo Nivuru. Per risolvere tutto quello che c’è dentro quelle canzoni bisogna che lo faccia almeno mille volte. Arriverà un momento in cui mi libererà”.
Quali sono gli ascolti, i libri o i film che più ti hanno influenzato/ispirato nel processo di scrittura del disco?
- “Potrei citare almeno 50 dischi da cui ho trafugato pezzi di musica, spunti e idee. Molti vengono dal Brasile tipo ‘A mulher do fim do mundo’ di Elza Soares, le meraviglie che scrive Djavan, tutto Marcelo Camelo,
il funk nordestino di Di Melo, ‘Acabou Chorare’ dei Novos Baianos, Clara Nunes, Caetano e Gil, gli Afrosamba di Baden Powell, insomma potrei stare qui per ore a elencare nomi di musica brasiliana. Poi c’è la grande radice africana dallo Gnawa alla Morna, dall’Afrobeat al Desert blues. Aziz Sahmahoui, Mayra Andrade, Fela Kuti, Rokia Traorè. E poi tutta la musica nordamericana, soul, black, neo-soul che non smetto di ascoltare e di trovare dentro la mia scrittura, dai grandi cantautori come Bob Dylan, Rufus Wainwright alle nuove bestie come Anderson Paak.
I libri. Beh, quelli che hanno influito visibilmente sulla cifra poetica del disco sono sicuramente La peddi nova di Ignazio Buttitta e i libri di Giuseppe Pitrè. Leggere di tradizioni siciliane e studiare la mia lingua mi fornisce una lente particolare attraverso la quale interpreto il mondo intero. Ma possono essere stati di ispirazione anche gli mille altri testi che ho letto durante la lunga lavorazione del disco e la scrittura delle canzoni, dai romanzi di Jorge Amado a Tiziano Terzani, e tutta la poesia che ho divorato negli ultimi anni, Garcia Lorca, Franco Arminio, Rilke. Film, beh ho perso un po’ l’abitudine di guardarli”.

E quali i viaggi, gli incontri che più ti hanno sorpreso, fornendo linfa vitale di idee e suggestioni utili alla composizione?
- “Ci sono dei viaggi che musicalmente hanno significato molto per me. Su tutti la mia esperienza a Barcellona. Sono entrato in contatto con un nuovo modo di vivere la musica attraverso una comunità brasiliana di musicisti formidabili. Poi la mia immersione nei festival di musica africana a Capoverde e in Marocco, sono stati dei veri bagni sacri”.
Hai aperto alcuni concerti europei della tournée di Max Gazzè: che tipo di esperienza è stata? Il pubblico presente conosceva già la tua musica? E che tipo di live dovremo aspettarci quando arriverà il momento?
- “E’ stata un’esperienza bellissima, un percorso di umiltà che non avevo mai affrontato, conquistarsi il pubblico di un altro artista nota per nota. Qualcuno già mi conosceva, la maggior parte no. La cosa che mi inorgoglisce è che alla fine del mio set il pubblico mi ha sempre chiesto il bis e questo non è proprio detto che accada quando aspetta il suo beniamino e a te non ti conosce proprio. Queste anteprime sono stati degli assaggi chitarra e voce tra ‘Sfardo’ e ‘Nivuru’. Ma io mi auguro che ‘Nivuru’ vada in giro sempre con tutta la band, stiamo mettendo su un live scoppiettante”.
L’album ha avuto una lunga gestazione: è stata una decisione di partenza, un intento preciso fin dall’inizio oppure i tempi si sono dilatati per altri motivi?
- “La maggiore causa di ritardo è legata ad una bella notizia: la pubblicazione, quasi inaspettata, di Sfardo a livello internazionale.
Ha richiesto tanto tempo per le traduzioni in 5 lingue e tanto lavoro per diramare la musica capillarmente in ognuno di questi 10 paesi.
Se avessi potuto scegliere, ‘Nivuru’ sarebbe uscito a metà 2017
(era già praticamente pronto) ma non mi lamento”.
C’è un brano che ti inorgoglisce più degli altri? Magari perché rischiava di non “nascere”?
- “Per me sono tutti dei figli. Una che mi piace molto è ‘Cafè’, secondo me può essere un buon riassunto del disco per l’atmosfera contemplativa iniziale, la furia, lo spessore profondo, l’urlo animale”.
Trovo che sia “Sfardo” che “Nivuru” siano album intimi, confidenziali, a modo loro fragili e delicati. Quello che cambia è il vestito, e quindi le sonorità, la strumentazione, gli arrangiamenti, insomma i colori e l’approccio nel ‘dipingere il quadro’. Forse il primo aveva radici più profonde in uno scrigno di ricordi dalla cornice folk, dalle risonanze quasi favolistiche, di fanciullezza perduta, mentre questo qui respira e balla nel presente e risulta più ‘adulto’ colorato, estroverso e sensuale. E trovo rappresenti anche una sfida e quindi un rischio verso quei fan che magari si aspettavano di restare ancora un po’ protetti da quella coperta calda, da quella tenda indiana che era il sound dell’album d’esordio…Sei d’accordo con queste ipotesi/suggestioni?
- “Io avverto comunque una grande differenza tra questi due dischi.
Si riconosce un filo rosso che li unisce. ma a me sembrano scritti da due persone diverse. E ancora non ho ben capito cosa veicola precisamente Nivuru, per questo è importante suonarlo dal vivo, mescolarlo alle reazioni delle persone, sapere cosa arriva a chi ascolta di tutta questa giungla”.

Lo scarto sonoro che c’è tra “Sfardo” e “Nivuru” mi ha ricordato da vicino il cambio di passo che un grande artista come Pino Daniele visse e raccontò nei suoi primi due album. Un debutto legato profondamente alla propria terra e quindi anche al ridare piena dignità, risalto alle radici folk, tradizionali/popolari. E poi, a pochi anni di distanza, vedi lo stesso artista prendere il largo e salpare lontano, tentato da altre sirene, nel suo caso verso l’America del rock/blues, del soul e del funky fusion. Ma senza mai tradire le sue origini: continuando perciò a cantare in dialetto e raccontando la sua città e la sua terra che in filigrana si rivela, filtrata attraverso altri colori, altri alfabeti sonori…
Al di là del paragone, senti di star compiendo un percorso affine?
- “Pino è l’artista che più mi sento di tirare in ballo quando devo descrivere quello che faccio. Se dico che canto in siciliano subito si pensa a tutt’altro, a una musica legata alla tradizione forse o alla world music siciliana degli anni ’90 che non amo particolarmente.
Se dico che uso il siciliano come Pino Daniele usava il napoletano
(non in termini in di qualità ma di approccio) mi sento più vicino alla verità del progetto”.
Hai mai scritto un brano in italiano finora? Se anche dovessi scegliere di esprimerti in dialetto anche in futuro (che in Sicilia ha il pregio, la dignità di una lingua) non so se sei d’accordo con quanto sto per dire: e cioè che ai tanti “non isolani” il tuo cantato potrebbe sempre e comunque evocare una sorta di ‘strumento’ risonante in armonia con gli altri, un suono puro espressivo/attraente a prescindere dal suo significato…
- “Ho scritto delle cose in italiano, saltuariamente, a volte scrivevo delle cose che andavano dentro degli spettacoli quando facevo teatro,
ad esempio. Ma non credo che questi esperimenti siano soddisfacenti come quelli in palermitano. Non ascoltando molta musica in italiano sono portato più a scrivere in altre lingue. Avevo iniziato con l’inglese, poi ho scritto delle canzoni in portoghese e qualche volta ancora ne scrivo,
il palermitano è proprio quella più autentica perché non arriva a me da nessuna influenza musicale ma solo dal mio vissuto. Sì, potrebbe essere qualsiasi lingua, in molti sono attratti da questi suoni, è una lingua arcaica e super contemporanea. è chiaro che per fare in modo che la gente sorvoli sulla questione linguistica la musica sul palco deve essere un fattore importante di modo che se vuoi goderti solo la musica puoi farlo. Poi se vuoi sapere cosa canto apri il libretto ed inizi a viaggiare dentro alle traduzioni”.
Non trovi che vivere lontano dalla tua isola ti dia l’opportunità di sublimarla e raccontarla forse in maniera ancora più autentica e poetica?
- “Sì, riconosco che la mia scrittura diventa più luminosa quando non sono a Palermo. Forse ciò è legato al rapporto complesso che ho con la mia città oppure al fatto che il mio animo si rivela più nel viaggio,
a temperature diverse rispetto a quelle in cui sono nato.
Oppure, semplicemente, ‘nemo profeta in patria”.
Intervista raccolta da Ariel Bertoldo