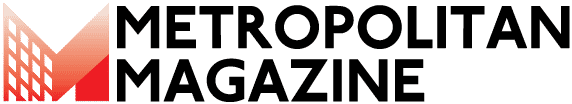E’ il pomeriggio del 18 maggio 2009, tre ragazzi a bordo di una Citroen C3 passano di fronte l’università Cattolica di Piacenza. Uno di loro si sbraccia e fa un gestaccio “di liberazione”, uno di quei rituali che serve a “celebrare” la fine degli esami. Non sapevano che quello sarebbe stato invece l’inizio dell’orrore. Perché proprio in quella frazione i ragazzi incrociano una macchina dei Carabinieri che, forse pensando di essere loro i diretti destinatari, li raggiungono, li fermano e li fanno scendere dall’auto. Come riportato dal Corriere, prima un pugno in faccia, poi “Levati testa di c…” dice un militare (Salvatore Cappellano), a Gianluca D’Alessio, uno dei giovani coinvolti: lo racconta lui stesso alla Guardia di finanza nelle indagini dei pm piacentini Matteo Centini e Antonio Colonna, coordinate dal procuratore Grazie Pradella. Dopo esser stati portati nella Levante, i ragazzi vengono pestati, umiliati e torturati. “Ci fecero sedere a terra ammanettati”, racconta D’Alessio, costretto a spogliarsi “completamente nudo” e perquisito, mentre uno dei suoi amici, Daniele Della Noce, viene portato in una stanza “trascinato per i piedi”, dopo esser stato scaraventato contro la porta che scardinandosi lo fa cadere a terra. D’Alessio confessa di essere “figlio di un capitano dei Carabinieri”, anche se il padre, ora impiegato all’Inps, si era congedato. Lo fa sperando di riuscire a destarli, ma in risposta arrivano botte anche per lui. Sempre sul Corriere si dice che Cappellano non smette neanche quando Gianluca urla che gli stanno rompendo un braccio: “Per me puoi anche morire”. Per 12 anni quelle umiliazioni hanno continuato a risuonare nella testa dei tre studenti. Ma la vicenda emerge solo adesso, in seguito alla denuncia del padre di D’Alessio, che per anni ha rifiutato la narrazione del figlio. Poi l’inchiesta che ha portato all’arresto dei militari e ora al processo per torture, traffico di droga e gravi reati. Allora si ricrede. Senza nessuna spiegazione che giustifichi l’arresto, i ragazzi furono lasciati per lungo tempo ammanettati, privati di acqua e senza la possibilità di chiamare famiglie o avvocati. Poi vennero trasferiti nella caserma di via Beverora, questa volta “trattati con gentilezza” dai Carabinieri. Il giorno dopo furono prelevati per il fotosegnalamento, e mentre attraversavano un cortile interno, Cappellano lasciò D’Alessio letteralmente appeso per le manette a un ramo di un albero, “costringendomi a rimanere in punta di piedi” perché più alto di lui. Un carabiniere di passaggio, sapendo che era accusato di aver aggredito dei militare, gli sferrò “un pugno in pieno volto”, mentre un altro lo tolse da quella disumana posizione dicendo: “Questo schifo non lo voglio più vedere”.
Piacenza, operazione “Odysseus”
Fu l’operazione “Odysseus” a rivelare come i carabinieri della caserma Levante di Piacenza si siano macchiati di una serie di pesanti crimini: abuso d’ufficio, violenza privata aggravata, tortura, estorsione, truffa ai danni dello Stato, sono solo alcuni esempi. Durante il lockdown, mentre c’era chi lottava contro il Covid, gli uomini dell’Arma, in accordo con una rete di informatori, avrebbero arrestato illegalmente alcuni pusher di piccolo calibro per impadronirsi dello stupefacente in loro possesso e rivenderlo sulle strade attraverso altri spacciatori di fiducia a cui offrivano protezione. Oggi i pm cominceranno l’arringa nel processo abbreviato prima delle richieste di condanna, che potrebbero superare i 15 anni di carcere. A causa della prescrizione, non possono procedere sulle aggressioni ai tre ragazzi che patteggiarono la pena per violenza e minaccia a pubblico ufficiale.
“La tortura è un crimine contro l’umanità”
Quella di Gianluca è una storia di ricerca disperata di giustizia, di sensibilizzazione su un tema tanto insidioso quanto troppo spesso taciuto. E in mezzo ce ne sono altre di storie, di cui non si è mai sentito parlare o che non hanno avuto l’attenzione che meritavano. Storie di omissioni, violenze, che compongono un’Italia di tanti Gianluca D’Alessio, per non parlare dei casi simili a quelli di Stefano Cucchi. Quello che viene messo in atto è un vero e proprio abuso di potere da parte delle forze dell’ordine. Perché a prevalere è troppo spesso la logica dell’autorità. Troppe volte dimentichiamo che “la tortura è un crimine contro l’umanità”, come ben sottolineava Patrizio Gonnella, presidente nazionale dell’Associazione Antigone, in un’intervista a RadioRadicale nel 2013: un concetto chiave con cui ha iniziato il suo lavoro di “decomposizione e dignità umana”, con la volontà di andare a ridefinire un “vocabolario della tortura“. Proprio la dignità veniva individuata da Gonnella come fondamento dei diritti umani. Nella storia del pensiero filosofico – diceva – la dignità umana è stata intesa in due modi diversi: una tendente a produrre fratture sociali, che è quella per cui la dignità umana è il decoro, il saper cioè stare in società, rispettare le regole. L’uomo degno è l’uomo decoroso, che si veste e parla bene, quello che non compie reati. E poi c’è un’altra dignità umana, che risiede nella grandezza dell’uomo, nella sua umanità. Citando Kant, Gonnella sottolineava quel pensiero secondo cui l’uomo non può mai essere ridotto a mezzo, l’uomo è sempre un fine. Per Kant l’uomo può essere il peggiore dei criminali, ma la dignità non viene mai meno. Ecco perché in qualche modo la dignità umana è la degradazione dell’uomo ad oggetto: una definizione in senso negativo. In quest’ottica, Gonnella faceva notare quanto nel nostro sistema costituzionale la dignità non avesse un’evidenza centrale, rispetto ad altri sistemi (quello tedesco, ad esempio). Nei vari articoli c’era un riferimento a diversi tipi di dignità (morale, sociale) ma nessuno di questi la contrassegnava come fondamento di tutti i diritti. Mentre per lui il riferimento giuridico alla dignità umana consentiva la possibilità di tutela. Perché “il divieto di tortura è categorico, non può mai essere formalizzato, neanche nel peggiore dei possibili rischi sociali. Se nell’opacità del sistema il poliziotto, rompendo la norma, usa la tortura, si deve assumere la responsabilità di quel gesto, e se quel gesto ha salvato una vita, sarà considerato un eroe ma pagherà per quel gesto da eroe”.
Nel luglio del 2017 è stata legge n.110 ad introdurre il reato di tortura, prevedendo la reclusione dai 4 ai 10 anni per chi causa sofferenze fisiche acute o traumi pisichici attraverso violenze e minacce gravi a una persona “privata della libertà personale o affidata alla custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza di chi commette il reato”. Tuttavia, il testo è stato snaturato rispetto a quello originale, presentato dal giornalista, ex senatore del Pd e presidente della commissione del Senato per i diritti umani, Luigi Manconi, il 15 maggio 2013. Lo stesso che si è astenuto dalla votazione in Senato perché il suo testo si riferiva fondamentalmente alla Convenzione delle Nazioni Unite, per il quale il reato non è misurabile sulla base dell’efferatezza o dell’intensità delle sofferenze che produce. “Non è un atto tra due individui capace di produrre sofferenze fisiche o psichiche, ma è l’atto commesso e realizzato da chi detiene legalmente il potere di tenere sotto controllo un’altra persona. Questa parola ‘legalmente’ è cruciale”, diceva Manconi in un’intervista a Left. Però in Senato non si è capito. Intanto per l’introduzione di quelle parole “più condotte”, che sembrano estendere la violenza a più giorni, per cui “la tortura c’è solo se e solo quando la condotta fatta oggi viene ripetuta”. E poi c’è la questione della violenza psichica, “e questa cosa mi ha proprio turbato”, diceva Manconi, “perché il trauma psichico, secondo la letteratura scientifica internazionale, non è qualcosa che si rileva con una tac, tanto più realizzata dopo tre anni. I processi di tortura si fanno dopo dieci, venti anni, ma cosa si può rilevare? Ho fatto una piccola ricerca e ho scoperto che la roulette russa, forse la più famosa tortura sotto il profilo dell’immaginario e dell’iconografia, non è rilevabile clinicamente”. Manconi ha pertanto definito “la classe politica italiana subalterna alle forze dell’ordine“. Un senso di dipendenza che in effetti si dimostra tutte quelle volte che, di fronte a determinate vicende, la tendenza è far in modo che “non si infanghi la divisa”, come disse Matteo Salvini. Questo tende a mettere lo sporco sotto al tappeto, non ad affrontare realmente il problema che l’Italia ha con le forze dell’ordine. Perché è puntando i riflettori sullo “sporco” che tutti gli altri agenti uscirebbero puliti. “Se noi sanzioniamo i responsabili di tortura salviamo l’onore di quelli che responsabili di tortura non sono”, faceva notare Manconi. Sanzionare vuol dire riconoscere lo sbaglio e fare in modo di eliminarlo per sempre. Distoglierne l’attenzione per spostarsi su chi lo sbaglio non lo commette significa far finta che non sia mai successo. Dipingerli come “eccezioni” orienta gli stessi cittadini a focalizzarsi su ciò che funziona. Non su quello che bisogna cambiare.
Manconi sollevava inoltre la questione della mancata formazione da parte dei corpi delle forze dell’ordine, che si traduceva nell’inadeguatezza della loro preparazione e nell’esigenza di una complessiva revisione del loro percorso formativo. In tal senso, gli atti di violenza non possono essere ricondotti esclusivamente a “eccessi” di singoli agenti, ma a “una complessiva esigenza di miglioramento, sotto il profilo deontologico e valoriale, della preparazione del personale di polizia”. Ma neanche l’impreparazione tecnica può giustificare la disumanità. Quella che dimostrano anche tutti quegli agenti che, pur rimanendo estranei ai fatti, seguono la strada dell’omertà, rimanendo in silenzio a guardare la condotta dei loro colleghi. Come avvenuto nel caso di Piacenza, ma non solo. Questa omertà è caratteristica di un sistema malato, un ambiente che si è rivelato, di fatto, antistatale e corrotto.
Le rivoluzioni culturali non si ottengono solo con le leggi, di cui l’Italia soffre di puntuale ritardo, ma è necessaria prima di tutto una presa di consapevolezza. Affinché il reato di tortura sia una pratica diffusa c’è bisogno di un sentimento di indignazione che provenga dalle forze dell’ordine stesso, e poi dai cittadini, che da essi traggono fiducia. La radice semantica della parola dignità è la stessa di indignazione, già questo presuppone un collegamento. Dunque dovremmo imparare ad immedesimarci anche nello sconosciuto, per capire che i prossimi potremmo essere noi, e avere la forza di generare altre indignazioni. La cultura che giustifica l’abuso toglie alla dignità il suo valore intrinseco che è quello di provenire dall’essere umano stesso. Non c’è azione, scelta o qualità che può privarci di questo status ontologico.
Francesca Perrotta