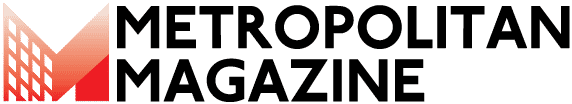Il consigliere comunale democristiano, Pompeo Panaro, è stato ucciso nel 1983 a Paola, in Calabria. Solo nel 2013 la magistratura a rinviato a giudizio uno dei suoi assassini. L’ex boss della ndrangheta è stato assolto perché il reato era ormai prescritto. Il figlio: “Trent’anni di omissioni e depistaggi”.
Pompeo Panaro era quello che si dice ‘un uomo per bene’, un facoltoso commerciante, un esponente della DC che aveva ricoperto diverse cariche pubbliche. A Paola, comune a quaranta minuti da Cosenza, negli anni Ottanta era titolare di un negozio di generi alimentari e di numerosi appalti per la gestione delle mense. Nel 1982 i suoi affari erano così fiorenti da segnare un fatturato annuo di 100 milioni. Numeri che facevano di lui un vero ‘notabile’ della provincia cosentina.
Il 28 luglio 1982 Pompeo Panaro chiude la serranda del negozio in via Duomo intorno alle 21. Deve andare a prendere sua moglie Silvana in piazza IV Novembre, ma non ha la sua auto, che gli è stata rubata. Si fa prestare quindi la Fiat 127 da suo cognato Francesco Surace, ma a all’appuntamento non si presenta. Da quel momento in poi non darà più sue notizie. La scomparsa di Pompeo Panaro, personaggio pubblico, denunciata dal fratello solo dopo quarantott’ore, il successivo 30 luglio, passa sotto silenzio. Da quel momento nessuno parla più dell’ex consigliere, nessuno fa domande. ‘Lupara bianca’ suggeriscono gli inquirenti, ma voci di paese dicono che Pompeo è ancora vivo, ed è tenuto segregato in via Baracche, dove la Fiat 127 che guidava la sera del 28 luglio è stata trovata regolarmente parcheggiata e chiusa a chiave dai carabinieri. Sulle ‘voci’ non vengono effettuati accertamenti.
Nel 1983 una segnalazione anonima porta la polizia in un bosco in località Trifoglio, dove i militari trovano un osso e alcuni brandelli di indumenti che si ritiene appartengano all’ex consigliere DC. I resti vengono riconosciuti dai fratelli Panaro, insieme a una ciocca di capelli trovata anch’essa sul posto. Il ritrovamento viene registrato in un fascicolo con intestazione ‘omicidio’, insieme alle foto. I giorni seguenti gli investigatori troveranno altri frammenti ossei appartenenti a un cranio, che, però, non finiscono nel rapporto finale della polizia. Nel 1984 l’osso viene deposto nella cappella di famiglia: Pompeo è stato ucciso e il suo corpo bruciato e abbandonato agli animali selvatici, fine della storia.
Invece no, perché la morte non viene riconosciuta. Nella cappella cimiteriale in cui i parenti depongono i resti (meno quelli del cranio, che non arriveranno mai nelle loro mani) non ci sono iscrizioni, non ci sono lapidi, lo stesso cimitero non registra la presenza di quelle spoglie. Pompeo non è morto, non per il Comune, nei cui uffici non viene consegnato alcun documento attestante il decesso. Ma le anomalie non finiscono qui. Nel 1997 il pentito Fedele Soria, del clan Serpa, rivela alla DDA i nomi degli assassini di Pompeo, il luogo e le modalità. Caso chiuso? Neanche stavolta. Alle dichiarazioni non segue il rinvio a giudizio dei presunti responsabili. Nel 2004 il caso viene archiviato.

Le successive inchieste ‘Costa’, ‘Missing’, ‘Iceberg’ e ‘Tela del Ragno’ della DDA di Catanzaro, condotte negli anni successivi nell’ambito dell’attività di contrasto alla ndrangheta, fanno nuovamente riferimento al caso Panaro come ‘scomparsa’ e ‘lupara bianca’. Perché? Per quale motivo la DDA ignora un fascicolo che documenta il ritrovamento dei resti, l’identificazione ufficiale e la restituzione per seppellimento? Anche in casa Panaro la vicenda è nebulosa. In famiglia nessuno parla di omicidio, tanto che quando un quotidiano locale ne riporta la storia come delitto di ‘ndrangheta, i fratelli del defunto si infuriano, minacciano di querelare il giornalista. Eppure sono stati propri loro a riconoscere e prendere in consegna i resti del congiunto. A rendere ancora più inquietante il quadro sono i fatti del 2007.
Il boss il pentito Giuliano Serpa fa ancora una volta il nome di Panaro, confermando la ricostruzione del primo pentito e autoaccusandosi del delitto insieme a un’altra dozzina di complici. Incredibilmente neanche stavolta si giunge a un processo.
Intanto Paolo Panaro, il figlio di Pompeo, per anni rimasto fuori regione per motivi di studio e tornato a Paola, comincia a fare domande agli zii e a sua madre. Ignora il ritrovamento dei resti attribuiti al cadavere di suo padre.
Nel 2011 il figlio Paolo scopre che sono presenti degli atti giudiziari sulla scomparsa del padre, avvenuta ormai 29 anni prima, dai quali risulta che la Procura di Paola aprì un fascicolo per omicidio volontario a carico di ignoti. La Polizia ricevette una telefonata anonima che segnalava il punto esatto in cui trovare il cadavere di Pompeo Panaro, in un bosco in Contrada Trifoglio. Eppure con la sua famiglia Paolo aveva inoltrato e ottenuto, tramite l’avvocato e amico Francesco Granata, la richiesta del riconoscimento di morte presunta (gallery). Come era stato possibile compiere quell’iter se esisteva in archivio il famoso fascicolo per omicidio? Se gli zii avevano voluto tacergli dell’omicidio, perché, all’atto della domanda di morte presunta le autorità non gli avevano fatto presente che esisteva il fascicolo?
Secondo il pentito Giuliano Serpa, il 48enne sarebbe stato eliminato perché ritenuto un informatore dei carabinieri. Le sue segnalazioni avrebbero fatto arrestare i latitanti di ‘ndrangheta che avevano ucciso il meccanico Luigi Gravina. Gli assassini del giovane, ammazzato per non aver voluto dare gratis dei copertoni a un boss, avevano in affitto alcuni immobili di proprietà di Panaro, che avrebbe quindi segnalato il loro nascondiglio. Nonostante il pentito – che si autoaccusa di aver partecipato al delitto – dichiari che furono in 13 a uccidere il povero Panaro, questi viene processato da solo. I complici? Sono tutti morti, dice la sentenza, eppure, nelle carte si legge che alcuni di loro all’epoca erano ancora vivi (alcuni lo sono tutt’ora) e si trovavano in carcere per altri reati.