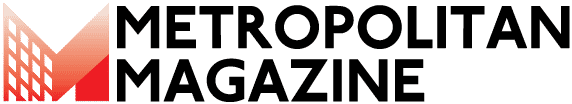Aung San Suu Kyi, la leader dell’opposizione birmana, premio Nobel per la Pace, dovrà trascorrere altri 33 anni dietro le sbarre. È il risultato dell’ennesima condanna da parte di un tribunale militare che, al termine di un processo-fiume andato avanti per 18 mesi, le ha inflitto 7 anni di carcere perché l’ha riconosciuta colpevole di 5 reati di corruzione.

Dal colpo di Stato del primo febbraio 2021 in Birmania, l’ex leader 77enne è prigioniera della giunta, in un carcere a Naypyidaw, accusata di una serie di reati: dalla corruzione ai brogli elettorali, passando per la violazione del segreto di Stato e quella delle restrizioni anti-Covid.
Quella che un tempo era la leader ‘de facto’ del Paese, poi disarcionata dalla giunta militare, ha affrontato in questi mesi l’ultimo processo, accusata di abuso di posizione di potere per l’acquisto di terreni e il noleggio di elicotteri; ma nei mesi scorsi, era già stata condannata a 26 anni di carcere, per quattordici capi d’accusa diversi. Secondo una fonte giudiziaria, comunque, in tribunale San Suu Kyi è apparsa in “buona salute”.
La storia di Aung San Suu Kyi
Ann San Suu Kyi è nata nel 1945 a Yangon ed è figlia di Aung San, eroe nazionale birmano e uno dei personaggi più famosi della storia moderna del paese. Aung San ottenne l’indipendenza del Myanmar dal Regno Unito dopo anni di lotta ma fu assassinato nel luglio del 1947, pochi mesi prima dell’indipendenza, che divenne ufficiale nel gennaio del 1948.
La madre di Suu Kyi, Khin Kyi, rimase una figura di una certa importanza, e nel 1960 fu nominata ambasciatrice in India. Si trasferì a Nuova Delhi con i suoi due figli, ma soltanto due anni dopo l’esercito birmano organizzò un colpo di stato e instaurò una dittatura militare nel paese. Suu Kyi, che al tempo aveva 17 anni, non sarebbe più tornata in Myanmar, a parte qualche visita occasionale, per 28 anni.
Suu Kyi frequentò dapprima le scuole di Nuova Delhi, poi si trasferì nel Regno Unito e si laureò a Oxford, dove studiò filosofia, politica ed economia. Trascorse un periodo a New York, lavorando per l’ONU, e nel 1972 sposò Michael Aris, uno storico ed esperto di buddhismo tibetano. I due si stabilirono a Oxford ed ebbero due figli, e per qualche tempo trascorsero una vita tranquilla.
Il New Yorker, in un ritratto pubblicato qualche anno fa, ha raccontato che Suu Kyi non smise mai di badare alla vita politica in Myanmar, e che si sentisse in un certo modo in dovere di recuperare l’eredità di suo padre, del quale in quegli anni pubblicò una breve biografia. Secondo il New Yorker, poco prima di sposare Aris, Suu Kyi gli inviò una lettera per spiegargli che se fosse stato necessario si sarebbe impegnata per il suo paese: «Ti chiedo soltanto una cosa, che se mai il mio popolo avrà bisogno di me, tu mi aiuterai a compiere il mio dovere nei suoi confronti».
Nel 1988 Khin Kyi, che al tempo viveva a Yangon, ebbe un infarto, e Suu Kyi tornò in Myanmar per accudirla. Trent’anni di dittatura militare avevano impoverito il paese, che era diventato uno dei più poveri del mondo. Proprio in quei mesi, a Yangon erano in corso grandi proteste studentesche: il generale Ne Win, che era stato l’autore del colpo di stato del 1962 che aveva instaurato la dittatura militare e che aveva governato in periodi alterni fin da allora, si dimise dalla carica di presidente. Quando, a partire dall’agosto del 1988, studenti e operai cominciarono a scendere in piazza per chiedere la fine della dittatura, i militari repressero le proteste con la violenza, e centinaia di persone (più probabilmente migliaia) furono uccise.
Suu Kyi si fece coinvolgere nel movimento per la democrazia. Anche se non aveva esperienza politica, in virtù della sua storia familiare un gruppo di ex militari, intellettuali e studenti le chiese di formare e guidare un nuovo partito, la Lega nazionale per la democrazia (NLD), e lei accettò.
Il 26 agosto del 1988 tenne il suo primo discorso pubblico a Yangon presso la pagoda Shwedagon, il luogo più sacro del buddhismo birmano, davanti a tantissime persone (si stima tra le 300 mila e il milione). «Come figlia di mio padre, non posso rimanere indifferente davanti a quello che sta accadendo», disse, lanciando «la seconda lotta per l’indipendenza nazionale».
Suu Kyi trascorse un anno di intenso attivismo politico, ispirata dalle teorie nonviolente di Mahatma Gandhi, in India, e dal movimento per i diritti civili di Martin Luther King, negli Stati Uniti. Nel maggio del 1989 il governo militare cedette alle pressioni e annunciò elezioni per l’anno successivo, ma poco dopo l’annuncio, Suu Kyi fu messa agli arresti domiciliari, senza processo, per aver «messo in pericolo lo stato». La NLD vinse la maggioranza assoluta, ma i militari ignorarono il risultato del voto.
Dei 21 anni tra il 1989 e il 2010, Suu Kyi ne avrebbe trascorsi più di 15 in prigione o ai domiciliari, chiusa nella villa della sua famiglia a Yangon.
In quegli anni, divenne uno dei prigionieri politici più famosi del mondo, oggetto dell’attenzione internazionale e di tantissime campagne per chiederne la liberazione. Ricevette il Nobel per la Pace nel 1991, e negli anni successivi fu più volte liberata e di nuovo arrestata: fu rilasciata per la prima volta nel 1995, ma fu messa ancora ai domiciliari nel 2000, rilasciata nel 2002 e poi di nuovo arrestata nel 2003. Parte del periodo di detenzione, Suu Kyi lo trascorse in isolamento, anche se periodicamente ricevette visite da membri del governo. In diversi momenti ebbe problemi di salute che la costrinsero al ricovero in ospedale.
Uno degli episodi più celebri e terribili della prigionia risale al 1999, quando a suo marito Michael Aris, che si trovava nel Regno Unito, fu diagnosticato un tumore in fase terminale. Il regime impedì ad Aris di andare in Myanmar per visitare Suu Kyi, ma si offrì di liberare la dissidente affinché potesse raggiungere suo marito a Oxford. Lei, sapendo che non sarebbe più stata in grado di tornare in Myanmar una volta uscita dal paese, si rifiutò. Aris morì pochi mesi dopo.
Nel 2010 il regime militare, che aveva cominciato a intraprendere una timida transizione verso una forma di governo più democratica, indisse le prime elezioni in vent’anni. Impedì a Suu Kyi di partecipare, ma la liberò sei giorni dopo, il 13 novembre.
Durante i suoi cinque anni di governo, Suu Kyi ha deluso gran parte delle aspettative che erano state riposte in lei. Sotto la sua guida, il processo di democratizzazione del Myanmar non è praticamente avanzato, anzi: in alcuni casi la situazione è peggiorata. Secondo gli esperti, per esempio, negli ultimi anni la stampa è diventata meno libera, anche a seguito di alcuni casi molto noti di giornalisti arrestati per aver criticato l’esercito o per aver raccontato cosa stava succedendo nelle aree di conflitti etnici. Anche internet è diventato oggetto di una censura crescente.
Suu Kyi e la NLD non hanno fatto praticamente niente per eliminare o modificare le leggi volute dal regime militare che minano la libertà d’espressione, e il numero dei prigionieri politici arrestati negli ultimi anni è tornato ad aumentare in maniera consistente.
Soprattutto, Suu Kyi è stata accusata di aver prima ignorato e sminuito e poi difeso la persecuzione della minoranza dei rohingya da parte dell’esercito. I rohingya, che professano fede islamica in un paese a stragrande maggioranza buddhista, sono considerati una delle minoranze più perseguitate del mondo: non godono del diritto di cittadinanza e da decenni sono ostracizzati dallo stato. Cominciata nell’agosto del 2017 con gli scontri tra l’esercito birmano e i ribelli rohingya nello stato del Rakhine, nell’ovest del paese, vicino al Bangladesh, la persecuzione divenne nel giro di poche settimane una campagna di violazione sistematica dei diritti umani, uccisioni indiscriminate, saccheggi e stupri di massa. Decine di migliaia di persone furono uccise, decine di migliaia di donne stuprate, e centinaia di migliaia di rohingya furono costretti a fuggire in Bangladesh. Diverse agenzie dell’ONU, organizzazioni umanitarie e governi hanno definito la persecuzione dei rohingya come un genocidio.