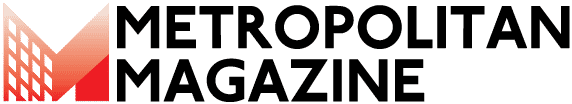Nell’esercizio critico e analitico di un film di Ari Aster, la difficoltà maggiore sta nel saper interpretare il materiale di partenza. Perché, per poter parlare di un film come Beau ha Paura, è necessario un grande lavoro di analisi di tutto ciò che il film ha da offrire. Sia da un punto di vista puramente tecnico sia ad un livello più profondo. Psicologico e psicanalitico. E risulta quanto mai necessario prendersi del tempo. Tempo per poter riflettere ed assimilare con chiarezza tutti i concetti espressi e poterli fare nostri. Tempo per comprendere, pensare e discutere di ogni singolo aspetto della pellicola. Ma, soprattutto, tempo per capire se dietro ad un film del genere ci sia del genio o semplicemente l’esaltazione fine a sé stessa di un giovane regista. Durante la visione di Beau ha Paura il metronomo si sposta continuamente tra le due sponde, rendendo praticamente impossibile farci rendere conto, ad una prima visione, quale delle due fosse. Ma con il tempo, appunto, ci siamo resi conto di essere davanti alla terza magnifica opera di un cineasta che si consacra come uno dei più talentuosi della sua generazione. È di certo un film destinato a dividere. Che verrà amato o odiato. Senza mezze misure. Ma rimane indubbia la bravura di Ari Aster e, per noi, la bellezza di questo suo terzo lavoro.
Beau ha Paura: Freud con i popcorn

Beau ha paura. Paura di uscire di casa, degli sconosciuti e paura di avere rapporti sessuali. Perché, a detta della madre, soffre della stessa malattia del padre: un problema cardiaco che lo porterà alla morte non appena raggiungerà l’orgasmo. Beau vive lontano da lei, in una New York violenta e distrutta. Così come il suo palazzo e la sua casa. L’indomani dovrebbe partire per andare a trovare la madre ma, per una serie di circostanze, gli vengono rubate le chiavi di casa e la valigia, lasciandolo per strada in balia di una città nel caos. Parlare di più di Beau ha Paura sarebbe un crimine contro lo spettatore e contro un’esperienza filmica che deve essere vissuta sulla propria pelle. Vi basti sapere che le conseguenze di questa catastrofe di eventi porteranno Beau tra strane famiglie, compagnie teatrali sinistre e tutto quello che di più meraviglioso e folle possa venirvi in mente. Un’avventura, una sorta di road movie e romanzo di formazione nel tentativo di tornare a casa in un racconto originale e sui generis. La sceneggiatura, in realtà, per quanto originale, è basata su un cortometraggio del 2011 sempre di Ari Aster intitolato, appunto, Beau. In questo lavoro embrionale del regista erano già presenti le caratteristiche che ritroviamo poi nel film. da un accenno di rapporto materno, fino all’incipit della valigia e le chiavi, che qui è rappresentato pari al corto. E allo stesso tempo, era già possibile intravedere la stravaganza di un regista che muoveva i suoi primi passi. Ma con le idee decisamente ben chiare.
In fondo, Beau ha Paura è un po’ il seguito spirituale dei primi due film del regista. Hereditary affrontava il tema della famiglia e dell’eredità, appunto. Midsommar l’elaborazione di un lutto e della fine di una relazione (che sono praticamente la stessa cosa). E Beau ha Paura l’inadeguatezza di fronte al mondo e di come il rapporto genitoriale formi questa mancanza sociale. La trilogia psicanalitica, la possiamo definire. Ari Aster utilizza, in pratica, il cinema come mezzo per esprimere i propri disagi interni. Come tramite per poter liberare la sua psiche, in una sorta di seduta dallo psicologo con la macchina da presa. Aster gira come se dialogasse con la macchina e con lo spettatore come terzo incomodo in questa chiacchierata. Guida lo sguardo in un urlo sempre strozzato e mai liberatorio. Come le parole che non escono a Beau o come gli urli sincopati di Dani in Midsommar. Pone al centro della sua idea di cinema le relazioni che non funzionano: dalla famiglia, rapporto non scelto. Passando per le relazioni, i rapporti che ci scegliamo. Infine, con questo ultimo film, per quelli con la società e soprattutto, con la madre, la prima figura con cui abbiamo a che fare. Il rapporto ancestrale e primario. La sua è una cinematografia che pesca a piene mani dalle teorie psicanalitiche freudiane e Junghiane. E Beau ha Paura ne è la riprova. Parla Freudiano quando pone il personaggio interpretato da Joaquin Phoenix in una situazione in cui la familiarità cessa di essere tale. Esattamente il momento in cui il perturbante freudiano nasce e prolifera. L’intero film è così: un personaggio che vaga in una landa di disperazione personale data dall’elemento della famiglia che smette di essere legato a lui. E la incapacità di esprimere le sue pulsioni sessuali, cardine tematico del film, a fare da padrone. E il prologo del film è chiarificatore: la nascita dal punto di vista del bambino e il taglio del cordone ombelicale, preludio al processo psicologico del film. Beau non ha mai superato la fase fallica freudiana, dato che ha rimosso i ricordi traumatici legati ad una madre abusante e non è mai riuscito ad esprimere la sua libido, data la sua paura della morte. Concetto espresso simbolicamente dalla statuetta che deve regalare alla madre: simbolo fallico che lui si porterà dietro per tutto il film, esternamente, quasi fosse un peso. Che regalerà poi solamente ad una donna per cui proverà attrazione sessuale. E allo stesso tempo, quando affronta quei ricordi/sogni (senza spoilerare), la figura che ne esce fuori è ancora simbolica. Relegata alla soffitta, nascosta nel subconscio e mai affrontata veramente. Beau non ha mai sviluppato una consapevolezza di sé, un super Io freudiano, appunto. Siamo sicuro che Freud e Jung si sarebbe fatti molte risate e avrebbero mangiato popcorn di gusto guardando questo film.
Un’idea chiara di Cinema
Nell’espressione di questi concetti e di questa sovrastruttura, Ari Aster gira un film a livello tecnico straordinario. A partire da tutti quegli elementi che rendono un film di Ari Aster riconoscibile dal primo frame. La sua classica camera fissa presa da un cinema Kubrichiano. I passaggi da un ambiente da un altro in piano sequenza. I repentini tagli per passare dalla notte al giorno con camera fissa. La sua panoramica verticale a 180 gradi usata per esprimere l’incertezza e il passaggio al mondo straordinario. Sono solo alcuni degli elementi ricorrenti nella poetica e nella tecnica di Ari Aster. Dei marchi di fabbrica, insomma. Tutti tecnicismi che fanno parte ormai del suo bagaglio che lo caratterizzano come autore. Difetto riscontrabile, però, è una lunghezza forse eccessiva della pellicola. La A24 è famosa per la libertà che lascia ai registi sul montaggio finale, senza imporre veri e propri paletti produttivi. Ma forse in questo caso sarebbe stato meglio guidare di più il regista, asciugando il film che risulta forse un po’ pesante date le sue tre ore. Ma a parte questo, il film è incredibile dal punto di vista tecnico. Ari Aster è un regista fenomenale: la sua idea di cinema è chiara dal suo esordio e la sua capacità di saper dialogare con le immagini qui prende un gusto tutto nuovo. La sequenza di quasi mezz’ora a metà tra la tecnica mista e i teatri di posa ci riporta ad un cinema primitivo, attrazionale. Sembra di essere quasi negli ambienti alla Fleming, alla Mago di Oz o nei teatri di Meliés. E il tema riflessivo non finisce qui: vi consigliamo di rimanere seduti e di gustarvi i titoli di coda, a mo di specchio sulla sala stessa e su di un menefreghismo dello spettatore stesso.
Una sceneggiatura che ha degli ottimi ritmi e una sottostruttura clamorosa. La fotografia incredibile di Pogorzelski che riesce a adattare la luce a tutte le folli di idee di Ari Aster, nella terza collaborazione che sancisce il loro sodalizio artistico. Il direttore della fotografia polacco cambia completamente i toni passando dalla luce accecante della famiglia che ospita Beau al gioco stroboscopico dei ricordi infantili e della figura materna. Il lavoro di ricerca è stato enorme e ha dato i suoi frutti. L’interpretazione di un fantastico Joaquin Phoenix, che ancora una volta interpreta un personaggio completamente fuori dai canoni comuni ma che riesce a non renderlo una macchietta ma che, anzi, lo fa proprio. E la scenografia incredibile di Fiona Crombie che aveva mostrato i denti con La Favorita di Lanthimos e che qui dimostra ancora una volta la sua bravura. Sono questi gli elementi che rendono, a nostro gusto, Beau ha Paura un film da non perdere. Solo la pazienza saprà dirci se saprà resistere alle pieghe del tempo che lo sancirà a capolavoro. Ma siamo sicuri di essere di fronte ad un nuovo grande regista e alla sua consacrazione come futuro del mezzo cinema.
Alessandro Libianchi