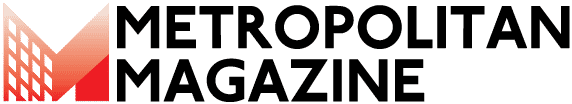A 12 anni di distanza da “Che pasticcio, Bridget Jones!”, nel 2016 usciva nelle sale il terzo film del ciclo: “Bridget Jones’s Baby”. Renée Zellweger rientrava allora nei panni dell’ormai quarantatreenne londinese, per raccontarci, di nuovo, la sua solitudine e la sua frustrazione.
La sceneggiatura ripropone lo stesso schema dei due film precedenti: Bridget torna, come un infallibile boomerang, nel suo ruolo di ciclicamente-single, ma è sempre più ossessionata dall’età che avanza e insoddisfatta di quanto non ha raggiunto nella sua vita di donna quarantenne.

L’eterno ritorno dello schema alla Bridget Jones
Facendo perno su un personaggio che non cambia mai, la trama del terzo film riesce a riproporre al pubblico gli stessi meccanismi dei primi due capitoli. L’insofferenza di essere single ricompare, nella rappresentazione della solitudine amorosa di Jones, come la peggiore delle maledizioni, che va sconfitta con ogni mezzo.
Anche la competizione tra i due pretendenti è cosa già vista. Ed uno dei due è niente di meno che l’uomo col peggior maglione natalizio di sempre, il caro vecchio Mr Darcy. Lui riemerge come una vecchia fiamma mai spenta dal passato di Bridget per ri-tentare, una terza volta, la relazione che per Jones, nonostante tutto, è quella con l’amore della sua vita. In questa pellicola però si riaffacciano con maggiore evidenza le ossessioni di Bridget, delineate sin dal primo episodio.
L’inizio del film in coincidenza con la data del suo compleanno, in quest’ottica, non è per nulla casuale. Grande protagonista della prima parte del film è infatti l’ossessione per la giovinezza perduta, che va di pari passo con quella per la maternità. Le due si sposano nell’espressione “primipara attempata” che, nello spirito della comicità poco sottile della trilogia, viene ripetuta più volte lungo la commedia per fini umoristici.
La terza ossessione riemerge con tutta la sua forza, amplificata anche dai fallimenti accumulatisi in un prologo che si estende per ben due film: quella per l’amore a tutti i costi. Dall’esterno non è difficile sottolineare che queste ossessioni sono frutto della pressione sociale, delle aspettative che hanno famiglia e società sul corpo di una donna e che, in questo caso, si concretizzano in un loro piccolo concentrato: nella produttrice televisiva di nome Bridget Jones.
Un guilty pleasure che parla alle nostre ossessioni
Guardando “Bridget Jones’s Baby” si ha quindi l’impressione di essere di fronte ad un film già visto: stessi personaggi, stessi equilibri, stesso lieto fine. Senza contare che, in un periodo in cui si fa molta attenzione alla rappresentazione che si dà delle figure femminili, la storia di Jones ha l’odore stantio delle commedie romantiche che riducono la donna a desiderare di essere compagna, moglie, madre e niente più.
Ma, allora, perché continua a piacerci tanto Bridget Jones?
Prima di tutto perché parla alle nostre insicurezze. Racconta di una parte di noi che vorremmo fosse scomparsa per sempre sotto il peso della nostra neonata coscienza femminista, ma che invece resiste, sostenuta da una capillare educazione culturale, sentimentale, sociale e dall’influenza esercitata da prodotti culturali, proprio come “Il diario di Bridget Jones”.
Ma, soprattutto, Bridget Jones ci piace perché è confortevole. Jones trova sempre il modo di rispondere alle aspettative che si hanno su di lei (non sempre nel modo più consueto, questo certo), appianando la distanza tra la sua inadeguatezza e le attese/pretese del mondo esterno. In un certo senso, quindi, la trilogia mette al centro della narrazione le nostre insicurezze e, parlandone, non solo le legittima, ma ci dimostra quanta soddisfazione può dare la realizzazione di desideri e sogni nati dalla necessità di corrispondere ad uno standard.
Il ciclo dedicato all’antieroina londinese asseconda le insicurezze di Jones riassorbendole nel sistema che le genera. Ci presenta immancabilmente un rassicurante lieto fine, preconfezionato, che non scomoda nessuno. Tantomeno Bridget. Nonostante i fallimenti e le condizioni sfavorevoli, lei non si reinventa mai, non cambia mai obiettivo, non ricalcola mai il percorso per arrivare a bastare a se stessa. E questo perché scostarsi dal modello è faticoso, richiede forza ed energia. Non è confortevole quanto rimanere per inerzia nello status quo.
Un pacchetto hollywoodiano
“Bridget Jones’s Baby” è il terzo capitolo di un guilty pleasure che corteggia il nostro senso di inadeguatezza. È un compendio delle ossessioni della donna moderna. E, al di là dei giudizi di merito, è anche un piccolo reminder del potere dell’industria dei sogni che, con narrazioni leggere e pacchetti di divi hollywoodiani sapientemente confezionati, ci vende sogni e desideri che abbiamo imparato a memoria, senza che fossero necessariamente i nostri.
Debora Troiani