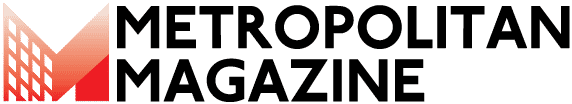Italia, siamo ad appena due settimane dall’inizio di gennaio. Giulia Donato, 23 anni, viene uccisa mentre dorme da Andrea Incorvaia. Martina Scialdone, 34 anni, viene uccisa con un colpo di pistola da Costantino Bonaiuti. Oriana Brunelli, 70 anni, viene uccisa a colpi di revolver da Vittorio Capuccini. Poi ci sono Maria Amatuzzo, Giovanna Frino, Alice Neri, e via via centinaia di nomi risalendo attraverso i mesi. Se questi sono i nomi delle prime vittime di femminicidio del 2023, è purtroppo così semplice dire che non saranno gli ultimi femminicidi di cui leggeremo quest’anno. C’è prevedibilità, costanza, anche immutabilità, nella sfilza senza fine di nomi di donne uccise per mano di uomo.
La domanda giusta da porsi sarebbe “perché?”, ma raramente ce la si pone. Per ogni donna uccisa vengono messe in fila dai giornali ragioni che tentano di giustificare un atto, si parla di rabbia, di raptus, di gelosia, di mostruosità innata ma, alla fine, la vera ragione per cui queste donne sono state uccise raramente viene svelata. La matrice culturale, strutturale, sistemica e patriarcale del femminicidio viene anzi completamente dimenticata quando c’è da scrivere o parlare della morte di una donna per mano di un uomo. Che siano telegiornali, quotidiani, testate online oppure social, il centro della vicenda non è mai “perché” ma è sempre “come”, “da chi”. E quindi ecco articoli con dettagli macabri ed irrilevanti, fotografie probatorie come se il popolo avesse bisogno di vedere il sangue e assaporarlo, testimonianze sull’innocuità dell’assassino e via così avanti per ore. Nessuna analisi sulla sistematicità degli omicidi e sul sistema che non è in grado di fermarli. Nessuna analisi sul sistema che li alimenta.
Quindi ecco che forse un primo passo possiamo farlo così, stilando una lista di elementi dannosi a cui troppo spesso di fa ricorso quando si parla di femminicidio.

Andiamo per ordine:
- Qual è la prima cosa che vediamo aprendo un articolo di giornale? La fotografia scelta per affiancare il testo. Non necessaria ma sostanzialmente onnipresente nel caso di articoli di femminicidi. Dov’è il problema? Il problema è che le fotografie scelte per fare da cornice ad un omicidio spesso sono fotografie che puntano a dare un giudizio morale sulla vittima oppure fotografie della vittima abbracciata dal suo assassino. Immaginate adesso la reazione di una vittima di stupro schiaffata in prima pagina mentre sorride a fianco del suo stupratore. Impensabile, mai darebbe il proprio consenso per una cosa del genere. E nemmeno le vittime di femminicidio, con ogni ragionevole certezza, eppure è quello che accade ogni volta. Fotografie di momenti felici dei carnefici con le loro vittime. Irrispettoso, violento, nonché controproducente ai fini di un’informazione che punti a educare la comunità sulla violenza di genere.
- Passiamo ai soggetti. Facciamo caso a come vengono raccontati. In una notizia di omicidio ciò che più dovrebbe contare è l’omicidio stesso, indistintamente dal ruolo, dalla classe sociale, dal mestiere, dalla nazionalità e dall’albero genealogico di vittima e aggressore. Ciò che accade tra le pagine dei giornali o in televisione è invece esattamente opposto. Vittime e aggressori vengono meticolosamente incasellati e analizzati (si fa per dire) secondo criteri i più stereotipati possibile. Così, se si parla della vittima, nel caso in cui lei facesse di mestiere la prostituta, voi lo scoprireste immediatamente, perché sarà scritto senz’altro a caratteri cubitali nel titolo dell’articolo. Allo stesso modo se l’omicida dovesse essere straniero, oppure un ingegnere di grande successo, voi lo sapreste immediatamente perché, anche quello, viene considerato essenziale. Il risultato? Persone che credono che la posizione e il ruolo di assassini e vittime contino a tal punto da definire alcuni assassini più colpevoli di altri, alcune vittime più innocenti di altre, e alcuni omicidi più gravi di altri.
- Adesso concentriamoci sull’atto. Femminicidio, omicidio, o anche violenza, abuso sessuale, stupro. Ogni cosa ha un proprio nome e un proprio significato nel linguaggio giuridico, e dovrebbe averlo anche nel linguaggio giornalistico. Il problema, però, è che troppo spesso la voglia di fare gossip, il desiderio di clickbait (o semplicemente l’ignoranza) portano chi scrive a usare termini sbagliati, alterando così la percezione di chi legge. “Per sei anni fa sesso con la figlia, 41enne alla sbarra” (TrevisoToday, 9 novembre 2021). Questa è una storia di abusi, di stupri, di violenza su minore, di pedofilia. Il titolo corretto sarebbe stato “padre pedofilo stupra la figlia minorenne”. Parlare indistintamente e bonariamente di “sesso” in un caso di abuso gravissimo non fa che sminuire il crimine, derubricare la violenza, attribuire alla vittima un consenso mai espresso. Utilizzare i termini giusti è fondamentale per parlare di violenza di genere.
- Una volta individuato il crimine, è il turno delle giustificazioni. Due parole che accostate non hanno molto senso, eppure è ciò che i media continuano a fare: giustificare femminicidi e violenze. Come? Affiancandoli a parole come “amore”, “passione”, “desiderio”. Forse nei momenti di fredda lucidità può apparire chiaro che passione e omicidio non abbiano nulla da condividere eppure ecco che giornali e televisione sono tempestati da narrazioni romanticizzate di “delitti passionali”, “amore criminale”, “amore malato” accostati a frasi come “l’amava troppo”, “il femminicidio prima dei loro anni più felici” arrivando così ai titoli in prima pagina: “Arrestato per amore” (Settimanale Fax, 11 dicembre 2021), “A giudizio lo stalker romantico” (La Repubblica, 8 luglio 2016) e quindi così via avanti per ore. Il risultato? Un’influenza gravissima sulla coscienza collettiva che continua ad essere nutrita con la tossica idea che, in fondo, anche un omicidio può essere un sintomo d’amore.
- Con le giustificazioni non è tutto, perché pur di alimentarle, insieme ai clickbait, troppo spesso i giornali o anche le trasmissioni televisive decidono di dare voce all’aggressore. Alla voce del carnefice viene data centralità, rilevanza, tempo, spazio, possibilità di legittimare anche il crimine più orribile attraverso le sue personali ragioni o esperienze. Iniziano così interminabili e strazianti colonne di giornale o palinsesto in cui non si condanna il gesto o la sua matrice ma si raccontano piuttosto le ragioni dell’assassino, a cui a volte si passa direttamente la parola, permettendogli di narrare il suo omicidio come la conseguenza disperata della fine della relazione o come l’effetto di una ragionevole gelosia, il tutto contornato dalla puntuale descrizione delle lacrime che tagliano il suo viso. E quindi, già dai titoli, i giornali raccontano: “Sebastiani in lacrime davanti ai carabinieri: ho fatto una stupidaggine” (La Repubblica, 8 settembre 2019), “Uccide la compagna, stupra e strangola la figlia 15enne e poi si uccide: lei voleva lasciarlo” (Il Messaggero, 7 febbraio 2020).
- Senza movente non c’è omicidio, i giornali lo sanno, è per questo che cercano di trovare ogni volta un movente anche nei casi di femminicidio. Ignorano, però, che il femminicidio in sé cela già un movente, altrimenti sarebbe un semplice omicidio. Femminicidio non è un omicidio di una donna. Se una donna viene uccisa perché si ritrova coinvolta in una sparatoria non è un femminicidio. Se una donna viene uccisa durante un furto al supermercato non è un femminicidio. Un femminicidio è se vieni uccisa PERCHE’ sei donna. Un femminicidio è un omicidio che ha come movente assoluto la voglia di ristabilire l’ordine in cui è l’uomo che decide. Che decide sulla vita, e anche sulla morte. Suppongo che, questo, giornali e televisione lo sappiano. Eppure la spasmodica ricerca di un movente non si ferma mai, ed ecco che subentrano parole come “raptus”, “gelosia”, “delirio”, “furia”, “crisi”. Il problema, però, è che queste parole non sono affatto la ragione dei 122 femminicidi avvenuti negli ultimi 12 mesi. Raptus e crisi non sono il movente, la forza matrice di questi assassinii. 122 donne gelose non hanno ucciso il proprio compagno durante il sonno nell’ultimo anno. 122 donne in preda a un raptus non hanno avvelenato l’uomo che gli stava a fianco. Questo perché la cultura strutturalmente patriarcale in cui siamo immersi, al punto da non accorgercene, si regge su un equilibrio di predominio degli uomini sulle donne il cui atto estremo è il femminicidio. Questo è il movente, la violenza strutturale che non si riesce a decostruire. La “gelosia”, il “raptus”, il “delirio” possono essere, semmai, il contesto nutrito da quella stessa cultura. I giornali, però, non lo dicono, e nei microfoni si continua a parlare di “gelosia assassina”.
- Se l’obiettivo di un articolo o un servizio su un femminicidio dovrebbe essere quello di informare la società su ciò che la circonda, ci sono alcuni pareri che contano e altri no. Se l’obiettivo è quello di notificare al mondo la gravità del gesto, ci sono alcune testimonianze che contano e altre no. E se la prospettiva di un uomo che ha appena ucciso una donna non conta niente nell’educare ed informare l’opinione pubblica, altrettanto valore ce l’ha l’opinione di conoscenti, vicini di casa, collaboratori, cugini di quinto grado. Cosa volete che dicano i dirimpettai con le finestre isolanti sull’uomo che abitava dall’altro lato della strada? “Sembravano felici”, diranno ai giornali. E cosa volete che dica una madre che ha appena scoperto di avere un figlio assassino? “era un figlio esemplare”, dirà piangendo. Il punto, però, è che non è così che si combatte la violenza di genere. Il primo livello per combatterla è identificarla e come può il pubblico identificarla in modo univoco ed irrevocabile se aprendo il giornale legge “Amanda, spinta sugli scogli dal fidanzato: sembravano felici, poi la lite” (Huffington Post, 12 giugno 2020).
- Il nostro penultimo punto di analisi parte con una domanda: 122 femminicidi in 12 mesi sono numeri più vicini ad una prassi o ad un’eccezione? Rielaborando, un femminicidio ogni 72 ore in media è più vicino alla norma o ad un gesto imprevisto? Mi sembra piuttosto chiaro che, statistiche alla mano, è alquanto inverosimile parlare dei femminicidi come di un’”emergenza”. Un’emergenza è qualcosa che si verifica sporadicamente; un’emergenza non può essere strutturale, cadenzata, perenne. Ecco, ci sono una serie di parole che andrebbero usate con attenzione quando ci si riferisce ai femminicidi. Il vocabolario che accompagna la notizia dovrebbe essere vicino alla dimensione del problema strutturale e molto lontano da quello dall’occasionalità del gesto. E invece, anche qui, l’informazione italiana ha un grande problema. Parole come “incubo”, “dramma”, “tragedia”, trasferiscono al lettore una dimensione di eccezionalità, di singolarità: lo trasferiscono lontano dal contesto che abita in cui, ogni 3 giorni, una donna viene uccisa. “Incubo ad Avezzano, marocchino, pesta e perseguita la moglie, italiana” (Il Primato Nazionale, 22 novembre 2022); “Dramma a Carignano, uomo spara e uccide moglie e un figlio prima di togliersi la vita: grave anche l’altra figlia” (PiazzaPinerolese, 9 novembre 2020). Un femminicidio non è una fatalità, non è un incubo: è la quotidianità di cui dobbiamo renderci conto.
- Ed ecco, infine, la domanda che avremmo dovuto porci fin all’inizio. L’informazione a cui avremmo dovuto avere accesso prima di tutte le altre: chi è stato ucciso?
- Non un numero, non un mestiere, non una nazionalità, ma una persona. Una donna che merita rispetto e, quindi, una sua identità. Non “Tre prostitute uccise a Roma” (Corriere della Sera, 18 novembre 2022), non “Colf, ucraina uccisa con 40 coltellate” (CataniaVera, 27 agosto 2014) ma nomi e cognomi. Queste donne assassinate sono persone che meritano giustizia e quindi, come minimo, che venga loro riconosciuto di avere un nome negli articoli che le riguardano. Ma forse il punto è che siamo andati troppo in là, siamo così abituati ai femminicidi che nemmeno ci premuriamo di capire chi sia la donna uccisa, di darle un’identità, rispetto, giustizia mediatica o collettiva. I femminicidi sono pane quotidiano, una triste abitudine di cui rendersi conto qualche volta la sera a cena con il tg in sottofondo. L’indignazione collettiva è ferma, la gente lo sa già che un’altra donna morirà eppure continua ad annuire guardando foto di assassini sorridenti. Forse il fatto è che la voglia di fermare la costante violenza di genere si riassume in vittime senza nome e in femminicidi raccontati come fossero gossip a pagina 20 dei quotidiani.