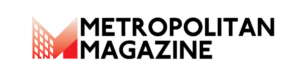Il Dialogo della Moda e della Morte di Giacomo Leopardi appartiene alla raccolta delle Operette morali scritte fra il 1824 e il 1832. In quest’opera lungimirante e attuale, Leopardi spiega il legame impercettibile agli uomini, seppur così saldo, fra la Moda, intesa come usanza o comportamento che l’umanità si affanna a seguire, e la Morte; condizione che tutto cancella. Entrambe sono infatti sorelle poiché figlie dell’effimero e della caducità.
Giacomo Leopardi, moda, morte e fuggevolezza: un parallelismo

Il Dialogo della Moda e della Morte di Giacomo Leopardi è uno scritto attuale quanto profetico dei tempi moderni. Composto a Recanati tra il 15 e il 18 febbraio 1854 è un dialogo che cita e celebra i Trionfi di Francesco Petrarca. Con il termine Moda si indica, di solito, un modo di comportarsi collettivo che precorre comportamenti differenti; eppure il termine non si riferisce esclusivamente alla necessità umana di abbigliarsi. Moda deriva dal latino modus, che significa maniera, norma, regola, ma anche tempo; Leopardi la utilizza nella sua concezione di ”usanza”, per l’appunto, nel suo dialogo con la Morte.
La Moda si presenta alla Morte come sua sorella, in quanto entrambe sono figlie della Caducità. Dopo le presentazioni la Moda parte con un decalogo di regole e usanze che gli esseri umani di ogni epoca compiono e percorrono realizzando, al contempo, le aspettative della Morte stessa. Due facce della stessa medaglia che portano allo stesso epilogo, nonostante l’umanità, sin dalla notte dei tempi, sia ignara di questa complementarità.
Moda: Io sono la Moda, tua sorella. Morte: Mia sorella? Moda : Sì, non ti ricordi che tutte e due siamo nate dalla Caducità? Morte: Che m’ho a ricordare io che sono nemica capitale della memoria. Moda: Ma io me ne ricordo bene; e so che l’una e l’altra tiriamo parimente a disfare e a rimutare di continuo le cose di quaggiù, benché tu vadi a questo effetto per una strada e io per un’altra.
La Moda elenca ogni dolore e sofferenza sperimentata per rispettare le consuetudini sociali, non tralasciando i vari esercizi per mantenere salubre corpo e anima, gli affanni per la ricerca dell’immortalità e del prestigio o la brama della gloria eterna che è una mera illusione; nonostante la spasmodica ricerca di rimanere su alte vette, nella vita di ogni uomo tutto a un tratto cala un sipario oscuro. Tutto è fuggevole, passeggero, inconsistente perché a trionfare è la Morte: la sorella maggiore della Moda.
Moda: Dico che la nostra natura e usanza comune è di rinnovare continuamente il mondo, ma tu fino da principio ti gittasti alle persone e al sangue; io mi contento per lo più delle barbe, dei capelli, degli abiti, delle masserizie, dei palazzi e di cose tali. Ben è vero che io non sono però mancata e non manco di fare parecchi giuochi da paragonare ai tuoi. […]
Io persuado e costringo tutti gli uomini gentili a sopportare ogni giorno mille fatiche e mille disagi, e spesso dolori e strazi, e qualcuno a morire gloriosamente, per l’amore che mi portano. Io non vo’ dire nulla dei mali di capo, delle infreddature, delle flussioni di ogni sorta, delle febbri quotidiane, terzane, quartane, che gli uomini si guadagnano per ubbidirmi, consentendo di tremare dal freddo o affogare dal caldo secondo che io voglio.
Appurata la parentela fra le due, Moda e Morte si mettono d’accordo per consultarsi, operare all’unisono, e trarre le migliori soluzioni da ogni situazione.
Giacomo Leopardi e la sfiducia verso la società dei consumi: la moda come simbolo della deriva consumistica
Giacomo Leopardi è un profeta del suo tempo; guarda con sfiducia al mondo che a lui è contemporaneo, una società fatta di produzione, consumi, albori di un capitalismo che sarebbe diventato sempre più pervasivo negli anni successivi. Per Giacomo Leopardi la moda è simbolo di pressappochismo in quanto simboleggia l’essere vanesi, la predilezione all’apparenza e la vana gloria caratteristiche tipiche del consumismo.Sempre secondo il poeta, le mode si susseguono continuamente in quanto una moda, per affermarsi, deve aspettare che quella che l’ha preceduta perisca. Ed è proprio in questo intersecarsi di coincidenze che Leopardi sottolinea il legame fra Moda e la Morte creando, addirittura, una sorta di genealogia mitica e presentandole come sorelle poiché, entrambe, immortali ma figlie della labile caducità.
«Leopardi inventa la “sua” genealogia mitica, alla maniera del Parini in più luoghi del Giorno, ma anche di Platone e degli gnostici. In questo punto va individuato il centro logico e poetico dell’operetta, quanto mai serio».
Giacomo Leopardi, Operette morali, a cura di Cesare Galimberti, Napoli, Guida, 19883, p. 103, n. 7
Il potere della moda, in un certo senso, coincide con quello dell’abitudine; un’assuefazione potente e senza tempo, una sorta di schematico uroboro in cui il concetto di Eterno Ritorno di Nietzschiana memoria ritorna a ripetersi perpetuamente. L’origine di questo aspetto complementare della Morte deriva, quindi, da quella della civiltà stessa e con essa va confondendosi. La Moda si presenta, in un primo momento, come una potenza metafisica e imperitura scevra dalla visione ”semplicistica” che la vuole come fenomeno socio-culturale moderno, accennando alla sorella Morte il loro comune modo di operare.
Giacomo Leopardi, la Moda e la Morte decisive per il destino dell’uomo: la prima impone tendenze, la seconda uccide
Quando, inizialmente, la Moda si presenta alla Morte quest’ultima le fa sapere di essere immortale ma subito l’altra ribatte affermando all’incredula foriera del sonno eterno il loro stretto legame. Entrambe, infatti, sono fautrici del destino dell’uomo: se la prima impone le proprie tendenze agli uomini, la seconda li fa perire. In questo gioco delle parti, l’uomo non ha alcun tipo di volontà né libero arbitrio; la Moda può imporre delle disposizioni che diventano cause scatenanti di malattie, o eventi tragici che possono portare al decesso.
E per cui la Morte, facendo proprio questo concetto della sorella, afferma che è per merito suo se esiste ancora la moda di morire; ma in realtà è la stessa – viva – esistenza a essere tacita e funerea. Attraverso i costumi la Moda impone agli uomini, quasi come un gioco, la vita stessa che è già morta nella suo sbiadito guizzo di vitalità. Infine, la Moda racconta di come tanti uomini, prostrandosi alla loro hybris, si siano vantati delle loro gesta considerandosi degli eroi immortali e di come le sue azioni abbiano arginato tale tracotanza; il ricordo di questi uomini sarebbe potuto essere imperituro nei posteri, ma lei ha fatto in modo che questo non avvenisse.
La ”morte sensibile”, ovvero la vita non vitale dei vivi dovuta ai progressi della civiltà e l’illusione della fama
Come lo stesso Leopardi afferma nello Zibaldone, l’operare della Moda cancella la facoltà di movimento, distinzione che la natura pone fra vita e morte; una stasi che il poeta definisce ”morte sensibile”, ovvero la vita non vitale. Uno stato di morte in atto del vivente a cui, inevitabilmente, l’uomo si piega e si semplifica per via dei progressi della civiltà. In altro senso si potrebbe dire che il poeta di Recanati aveva già predetto il potere del Capitalismo; o, per meglio dire, la stessa logica dell’edonismo del consumo che Pier Paolo Pasolini aveva sottolineato negli Scritti Corsari: la ricerca costante di un profitto che produce modelli i quali si affermano nell’omologazione.
Ma la Moda distrugge anche l’ultimo appiglio di immortalità dell’uomo; la speranza di vivere nella memoria dei posteri attraverso le opere e le proprie azioni. Se prima c’era la speranza a mediare fra la vita e la morte e a consolare l’uomo, nella sua idea di immortalità attraverso le impronte del suo passaggio sulla terra, l’ultima parte del dialogo diviene emblema della vita caduca; la caducità si trasforma ora in oblio, un’azione non solo riferita al dissolversi del corpo ma che colpisce le opere e la speranza che quella fama acquisita in vita rifulga nella memoria di chi verrà dopo.
Il potere della Moda, per Leopardi, è talmente sconfinato che diventa incarnazione e simbolo della modernità e della sua decadenza che, irrimediabilmente, rappresenta l’affannarsi impetuoso verso la Morte. Per quanto nel pensiero comune la diade Moda-Morte possa apparire un legame naturalmente idiosincratico, Giacomo Leopardi insegna come due aspetti così diversi siano fittamente correlati nella loro ambivalenza.
Stella Grillo
Foto in copertina: “All Is Vanity” by C. Allan Gilbert
Seguici su Google News