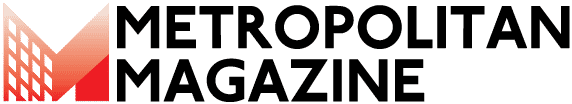Un po’ come quando vorresti rispondere sinceramente alla domanda “come stai”, e poi ti limiti a un generico “tutto bene”, dire che la fluidità di genere sia solo una moda piuttosto che “un capriccio dei più giovani” rivela superficialità e inesattezza. Un pressappochismo che diventa nocivo nell’ottica in cui ci spinge non solo a non approfondire noi stessi, come fa quell’espressione, tutto bene. Ma anche a non approfondire il mondo che ci sta attorno e che evidentemente, invece, ha qualcosa da dire in merito a come si sente. Gender fluid, agender, genderqueer, non-binary. Queste parole guardano a un unico comune bisogno: la libertà, la massima libertà a cui un individuo possa aspirare.
Sembra basti accendere Netflix oggi per avere l’occasione di conoscere, ma soprattutto accogliere, le diversità di genere. Chi, come me, ha superato ormai la pubertà, ma continua ad appassionarsi alle serie tv per adolescenti, non può infatti non accorgersi di quanto venga naturale tornare indietro nel tempo per riscoprire in qualche modo sé stessi, con la possibilità di addentrarsi in uno scenario in cui finalmente legittimarsi e sentirsi accettati o, perché no, desiderare d’esser qualcun altro. Non solo grazie a delle trame che si rivelano sorprendentemente interessanti e capaci di sollevare questioni su cui nel nostro tempo è importante più che mai riflettere e informarsi. Ma per l’intelligenza degli autori di costruire e valorizzare identità, caratteri specifici e personalità che difficilmente scadono nel cliché. Mi viene in mente Sex education, miglior teen drama del momento, la cui terza stagione – uscita lo scorso 17 settembre – ha già fatto venir voglia del continuum in virtù della capacità di mostrare al pubblico quanto di fatto tutto sia normale: questa nuova stagione non ha perso ma anzi guadagnato la capacità di “illuminare”, anche tramite il coinvolgimento di nuovi personaggi nel cast, come Isaac, volto noto a partire dalla seconda stagione, la cui disabilità viene raccontata e trattata nel modo più sano e naturale possibile, lasciando così spazio a un tema che quasi mai viene esplorato all’interno della serialità; e Cal (Dua Saleh), student* che si identifica come persona non-binary e che si ribella all’imposizione della divisa a scuola, rivelandosi uno dei personaggi più anticonformisti e positivi mai rappresentati prima, portavoce di una comunità a cui sembra non sia ancora concesso, nel 2021, manifestare liberamente la propria identità. Ma non solo.
Tematiche come il sessismo, l’omosessualità, il razzismo, la depressione, sono ormai costanti nei prodotti del catalogo Netflix, mai banali, presentati con la capacità di non voler dare giudizi. Quello che viene da pensare è che ci sia effettivamente la volontà di aprirsi a un universo in cui ognuno abbia la possibilità di riconoscersi e, contemporaneamente, di esplorare l’altro, afferrandone gli aspetti che spesso si tendono a nascondere o di cui si preferisce non parlare perché destabilizzanti rispetto a quell’idea di normalità tanto cara ai più.
Soprattutto quando si parla di identità, abituati alla classica dicotomia uomo/donna, fatichiamo ancora molto a comprendere, accettare o anche solo tollerare, tutte quelle persone che in questa conformità ci stanno un po’ stretti. La percezione di un’identità non binaria, in particolare, dal punto di vista sociale si percepisce spesso solo come indice di una confusione passeggera o come un riflesso della precarietà tipica dei tempi attuali. In realtà, il genere non-binary, anche detto genderqueer, nell’ampio e complesso spettro di vissuti ed espressioni identitarie che esso comprende, è riconosciuto in diversi contesti storico-culturali, e la sua presenza è testimoniata da numerose documentazioni presenti nel corso dell’intera storia del genere umano.
Questa espressione, non-binary, indica tutte quelle persone che vivono la propria identità di genere in modo difforme al binarismo di genere, non riconoscendosi cioè esclusivamente nel genere maschile o in quello femminile, ma in uno o più generi che fluttuano tra questi, li attraversano o se ne discostano completamente. Si definiscono precisamente genderfluid tutte quelle persone che si identificano in qualsiasi momento con un genere diverso; agender chi non si identifica in alcun genere; bigender o polygender chi si identifica simultaneamente e/o alternativamente in due o più generi; e ancora demigender chi sente solo una parziale connessione con un’identità di genere (demiboy/demigirl). Questo perché, nonostante i sessi appaiono binari, non c’è ragione di assumere che anche i generi siano solo due. Come scrive Judith Butlerin in Questione di genere: il femminismo e la sovversione dell’identità, “presupporre che il genere sia binario ribadisce implicitamente la convinzione che il genere sia in relazione mimetica con il sesso, e che dunque lo rispecchi o ne sia altrimenti limitato. Se si teorizza lo statuto di costruzione del genere in quanto radicalmente indipendente dal sesso, il genere stesso diventa [invece] un artificio fluttuante, con la conseguenza che termini come uomo e mascolinità possono significare con la stessa facilità un corpo di sesso sia femminile sia maschile, e termini come donna e femminilità un corpo di sesso sia maschile sia femminile”.
Sentendo la loro identità di genere non propriamente allineata al genere assegnato loro alla nascita sulla base del sesso biologico, le persone non-binary vengono tra l’altro spesso raggruppate nella categoria di persone transgender, un termine ombrello che non permette tuttavia di evidenziare le differenti esigenze, peculiarità ed esperienze di vita appartenenti ad ogni essere umano. Se infatti nelle persone transgender è tipico che si sviluppi un desiderio di appartenere a quello che, secondo il sistema binario, è il genere opposto a quello attribuito loro alla nascita, per le persone non-binary o genderqueer è lo stesso dualismo maschile/femminile a provocare disagio, essendo inadeguato a riflettere il genere percepito come proprio. Ecco perché non tutti sentono il bisogno di sottoporsi a trattamenti di tipo medico, come operazioni chirurgiche o terapie ormonali affinché il proprio corpo rifletta l’identità di genere percepita come propria. Per queste persone è spesso sufficiente un cambio anagrafico del nome o mutare la propria espressione di genere.
La mancanza di visibilità, unita all’assenza di sensibilizzazione e di informazione su certe tematiche genera non pochi problemi se si considera quanto spesso le persone stesse hanno difficoltà a capire la propria identità di genere, proprio a causa dell’indisponibilità di risorse o di canali educativi di riferimento. Chi ritiene che etichette quali genderfluid, non-binary, agender, siano esclusivamente una scelta di “forma”, non considera il potenziale che quella stessa etichetta porta con sé: basti pensare alla semplice possibilità di identificarsi, sentire di essere parte di una comunità nella quale sentirsi più o meno accolti. L’assenza di etichetta rappresenterebbe l’impossibilità stessa di sapere d’esistere. Ecco perché, oltre a questo, è importante rintracciare, persino inventare termini, espressioni linguistiche, categorie, entro cui la propria esperienza possa essere significata e ricompresa. In tal senso, una ricerca del 2019 ha scoperto che utilizzare un pronome neutro rispetto al genere riduce i pregiudizi e aumenta sentimenti positivi nei confronti delle donne e delle persone LGBT+: un piccolo cambiamento nel linguaggio che, tuttavia, secondo i ricercatori, aiuta ad eliminare le disuguaglianze di genere e a fare un passo “verso la creazione di un mondo in cui tutti siamo accettati senza eccezioni”.
Francesca Perrotta