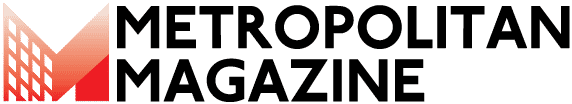Le parole non servono solo per descrivere la realtà, ma anche per riconoscerla: esse sono la più grande fonte di veicolazione di idee poiché in grado sia di fomentarle che di distruggerle. Prima di addentrarci nei rapporti di potere che si instaurano nel linguaggio e che hanno condotto all’aspro dibattito sui femminili professionali, si rende necessaria una premessa: non è la lingua italiana in sé ad essere sessista, ma l’uso che le persone ne fanno di essa. Si vedrà come, nonostante a differenza di altri idiomi nell’italiano non esista la declinazione neutra, comunque il genere grammaticale femminile non viene utilizzato anche laddove dovrebbe e, spesso, il suo significato assume una connotazione diversa rispetto al suo equivalente maschile.
Perché i femminili professionali fanno paura?
La questione linguistica, o meglio sociale, ha destato scandalo a partire dall’utilizzo della desinenza femminile per i nomi di alcune professioni che per molto tempo sono state di appannaggio esclusivo maschile: si tratta di lavori quali ministro, assessore, sindaco, magistrato, avvocato, ingegnere, e così via, i quali, essendo ricoperti da donne, sono declinati, rispettivamente, in ministra, assessora, sindaca, magistrata, avvocata, ingegnera, solo per citare alcuni esempi.
Il dissenso nato attorno a questi casi si è basato su diverse giustificazioni: in primis, questi sostantivi sono stati definiti dei neologismi, poi ci si è rifatti alla motivazione del “suono cacofonico” e delle assonanze, e ancora, alla vexata quaestio del “non è importante la forma ma il contenuto”, poi ad una “forzatura del femminile”, al politically correct, alla decadenza della lingua italiana e persino al fatto che il correttore ortografico segni dei femminili come errore.
Partendo dalla prima constatazione, si è già detto come non si tratti di parole inedite, ma piuttosto della presenza inedita delle donne in settori di potere che in passato erano loro preclusi: si è sempre utilizzata la parola “imperatrice”, allora perché desta cotanto orrore utilizzare quella di “rettrice” o “procuratrice”?
La presa di posizione di chi, poi, si rifà alla cacofonia e alle assonanze è priva di fondamenti reali: perché mai si dovrebbe accettare “maestra” ma non “ministra”?
Oppure, qual è il nesso che collega il nome professionale “architetta” ad una parte del corpo femminile, mentre dire “fallo dalla tre quarti” non richiama alla mente l’organo maschile?
E ancora con quale criterio si giudica la parola “arbitra” cacofonica e orripilante ma il medesimo sconcerto non si manifesta per “otorinolaringoiatra”?
Con riferimento invece all’astio nei confronti del cambiamento, giustificato dalla tesi del benaltrismo e dell’importanza del contenuto, si vuole riportare un episodio fonte di un profondo dibattito: durante il Festival di Sanremo 2021, Beatrice Venezi ha dichiarato sul palco dell’Ariston di voler essere chiamata “direttore d’orchestra” poiché, aveva affermato la stessa:
“quello che per me conta è il talento e la preparazione e soprattutto il ruolo, in un contesto molto tradizionalista e conservatore come quello della direzione d’orchestra e della musica classica. È fondamentale per una donna che non venga discriminata e chiamarla direttrice è quasi una discriminazione perché vuol dire che non ti mettono nello stesso insieme di tutti i direttori d’orchestra, è questa la verità”.
Tralasciando il fatto che, tecnicamente, il termine giusto per definirla fosse “direttrice”, il problema non riguarda tanto questo, essendo qualunque persona libera di farsi chiamare come meglio crede, anche a discapito dell’italiano, ma piuttosto la motivazione a sostegno della sua scelta: Venezi ha fatto una generalizzazione talmente ampia da abbattere, in pochi minuti, il lavoro e le lotte di anni, di milioni di femministe.
Non solo ha lasciato intendere che utilizzare il lemma nel genere femminile sminuisce il suo ruolo in un mondo quasi interamente dominato dall’uomo, ma ha anche affermato che un nome vale l’altro, ergo che non è fondamentale il riconoscimento del valore identitario.
Sul primo punto si può in parte concordare: è innegabile come il nome di alcune professioni assumano un significato diverso a seconda che se ne parli in termini maschili e femminili, come nel caso di “segretaria”, che nell’immaginario comune si identifica con una donna che prende appuntamenti e organizza l’agenda per un altro soggetto; mentre il “segretario” porta alla mente un uomo di prestigio che ricopre una carica elevata.
Ovviamente si tratta di un’interiorizzazione dovuta a contesti stereotipici che però andrebbe superata, non avallata, e che vede il nome di un ruolo declinato al femminile come defalcante rispetto all’autorevolezza emanata dal corrispettivo maschile.
Sul secondo punto invece, occorre soffermarsi maggiormente, perché rischia di far passare un messaggio con conseguenze irreparabili.
I latini direbbero “nomina sunt consequentia rerum”: i nomi sono conseguenza della realtà delle cose, significa che se una cosa non la si nomina vuol dire che non esiste.
Definire i femminili professionali con i propri nomina agentis dimostra l’esistenza di una donna in una determinata posizione lavorativa, simboleggia la possibilità a cui ogni persona appartenente al genere femminile può aspirare: dato che l’asimmetria semantica e discorsiva deriva da quella sociale, normalizzare l’utilizzo delle forme femminili aiuta a normalizzare la visione delle donne in ruoli di potere o, semplicemente, in contesti professionali in cui, per antonomasia, erano assenti.
Consigli per controbattere ad argomentazioni fallaci
Per quanto riguarda il concetto di “forzatura” e del famoso politicamente corretto, questi si realizzano piuttosto al contrario, quando si forza la lingua con il maschile sovra esteso, nonostante sia possibile far uso del genere femminile: risulta alquanto ilare la frase “l’ingegnere ha dato alla luce una bellissima bambina”.
Inoltre, non è pensabile che in una delle quattro antifone mariane, la “Salve Regina”, si sia voluta attuare una correttezza politica definendo la Madonna “avvocata nostra”.
Sul punto di vista di chi denuncia la decadenza della lingua e la sua mortificazione attraverso l’utilizzo di questi sintagmi si rimanda a quanto detto inizialmente, e cioè che si tratta solamente di rispettare il meccanismo sintattico ma, per coloro che invocano la locuzione “o tempora, o mores”, si ricorda che il suffisso -essa era utilizzato comunemente per indicare le mogli dei soggetti di cui si parlava, quindi ad esempio, la “dottoressa” era la moglie del dottore, non colei che svolgeva tale professione.
Ragion per cui, ci si dovrebbe riferire a questa figura nei termini di “dottora”, come a suo tempo propose Alma Sabatini, ma l’indirizzo che si segue attualmente è quello di non modificare i nomi femminili entrati a far parte del linguaggio popolare, come appunto “dottoressa”.
Infine, sulla segnalazione dell’errore da parte del correttore ortografico si puntualizza come esso si basi su un database di parole, che non per forza equivale ad una correttezza linguistica infallibile.
In verità, ulteriori fallaci argomentazioni vengono tirate in ballo da parte di chi è ostile verso l’utilizzo dei femminili professionali, tra le più ambigue vi sono il concetto di economia linguistica e quello di immutabilità dello spazio linguistico: a proposito del primo, si tratta di una scelta personale che, però, non tiene conto delle diverse soggettività e che viene quindi percepito come “non aperto”; sulla seconda teoria si può affermare con certezza che si tratta di un’erronea convinzione, in quanto la lingua non è cristallizzata ma, al contrario, viene plasmata attraverso i mutamenti del modo di guardare il mondo nell’essere umano.
Martina Di Santo
Seguici su Metropolitan Magazine