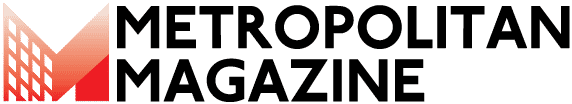Marcus Tullius Cicero, noto a tutti come Cicerone, è stato senza dubbio uno degli uomini di maggior rilievo nella storia di Roma. Nato ad Arpino nel 106 a.C., fu avvocato, filosofo, politico, scrittore e, soprattutto, oratore. Proprio tramite le sue celebri arringhe, attirò su di sé l’ammirazione, ma anche l’odio di diverse figure di potere. Se le Catilinarie, forse le sue orazioni più celebri, lo avevano consacrato tra i personaggi di spicco della Repubblica, le Filippiche segnarono la sua condanna a morte, che avvenne il 7 dicembre del 43 a.C.
Le Philippicae orationes si scagliavano contro Marco Antonio, impegnato nella lotta per la guida dei populares dopo la morte di Giulio Cesare, perito sotto ventitré pugnalate nelle famose Idi di marzo. L’interferenza dell’Arpinate nell’ascesa dell’ex luogotenente, e la veemenza usata negli attacchi contro la sua figura, inasprirono un contrasto che durava già da tempo. Il senatore, ormai anziano, era stato un convinto oppositore di Cesare e, pur non avendo partecipato attivamente al suo omicidio, era probabilmente al corrente della congiura, tanto che Bruto, con il pugnale sporco di sangue ancora in mano, si era rivolto ad esso come colui che avrebbe salvato e liberato la patria. Dopo l’esilio dei cesaricidi, il suo interesse si era concentrato su Ottaviano, figlio adottivo del defunto dictator e suo erede designato. Egli era considerato da molti come un dono dagli dei, inviato per ristabilire l’ordine, e lo stesso Cicerone apprezzava la sua linea politica moderata e filosenatoriale. Si schierò apertamente dalla sua parte; mossa che, tuttavia, gli si ritorse contro.
Cicerone: le liste di proscrizione e la condanna a morte

Ottaviano, dopo una serie di scontri con Marco Antonio, strinse un accordo con lui e con Marco Emilio Lepido, costituendo il secondo triumvirato. Fu chiaro da subito, per Cicerone, che il suo sogno di assistere e di istruire il giovane princeps affinché riformasse la res publica, era ormai svanito, ma non arretrò di un passo nelle sue accuse contro lo spregiudicato militare e confermò quanto affermato nella sua orazione. Di rimando, il triumviro lo fece inserire nelle liste di proscrizione, decretando, di fatto, la sua fine. A poco erano valse le deboli contestazioni da parte del futuro imperatore Augusto, il quale, in fondo, diffidava dell’avvocato di Arpino. E ne aveva ogni ragione, poiché questi, in privato, tramava contro di lui, affermando: «Quel giovane dev’essere lodato, onorato ed eliminato».
La notizia raggiunse lui, il fratello Quinto, anche lui presente nella lista, e il nipote, mentre si trovavano nella loro villa a Tuscolo. In fretta e furia, corsero nei loro possedimenti ad Astura, da dove avevano intenzione di salpare per la Macedonia e raggiungere Bruto. Quinto, però, tornò indietro insieme al figlio, per assicurarsi delle provviste. Un errore fatale: i due furono traditi da alcuni servi, e vennero assassinati. L’Arpinate, intanto, si era imbarcato su una nave, ma decise di farsi lasciare al Circeo, per tornare a Roma. Cambiò nuovamente idea a metà tragitto, si diresse ancora verso Astura e poi si fermò nella sua villa a Formia, assalito dai dubbi. Quando venne a sapere dell’imminente arrivo dei soldati di Marco Antonio, si fece portare verso Gaeta. Era il 7 dicembre del 43 a.C.
L’esecuzione e l’accanimento: la triste fine dell’Arpinate
I sicari avevano trovato una casa vuota, ma erano stati indirizzati da un liberto, che aveva svelato loro il piano del suo signore. Quando Cicerone li vide arrivare di corsa, non tentò la fuga, ma fece fermare la lettiga sulla quale stava viaggiando, e sporse il collo fuori dalla vettura, andando incontro al suo destino. Venne sgozzato dal centurione Erennio e poi, per ordine del mandante dell’esecuzione, gli furono tagliate testa e mani, proprio quelle mani che avevano scritto, non molto prima, quelle Filippiche che gli erano costate la vita. Una fine così cruenta da lasciare il segno, anche nel posto in cui il crimine era stato commesso, da allora chiamato Vindicio, vendetta.
Lo scempio perpetrato sul cadavere del poveretto non finì così: secondo lo storico Cassio Dione, infatti, la moglie di Marco Antonio, Fulvia, ne trafisse la lingua con una spilla per capelli. Un gesto crudele, per mettere a tacere, ormai tardivamente, quella bocca che tanto aveva diffamato il marito. Le mani e la testa dell’Arpinate furono portate a Roma ed esposte in senato, sopra la tribuna da cui gli oratori erano soliti parlare. Uno spettacolo macabro, ma simbolico. Un monito per tutti i presenti e non solo, un invito più che esplicito a non immischiarsi nelle faccende politiche. Così moriva Marco Tullio Cicerone e, insieme a lui, anche quella Repubblica che egli aveva strenuamente difeso, fino al suo ultimo giorno.
Federica Checchia
Seguici su Google News